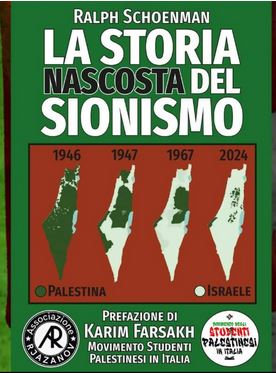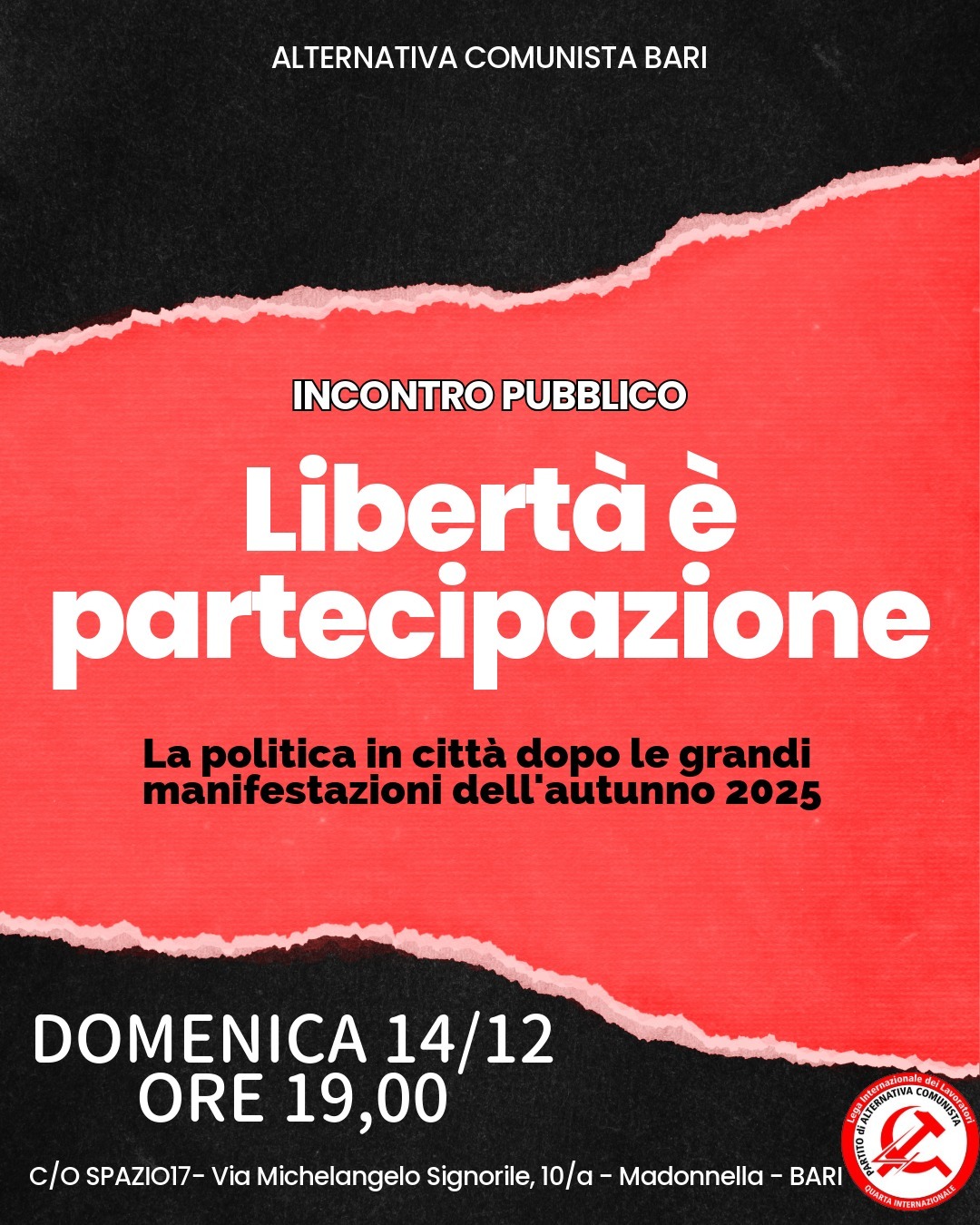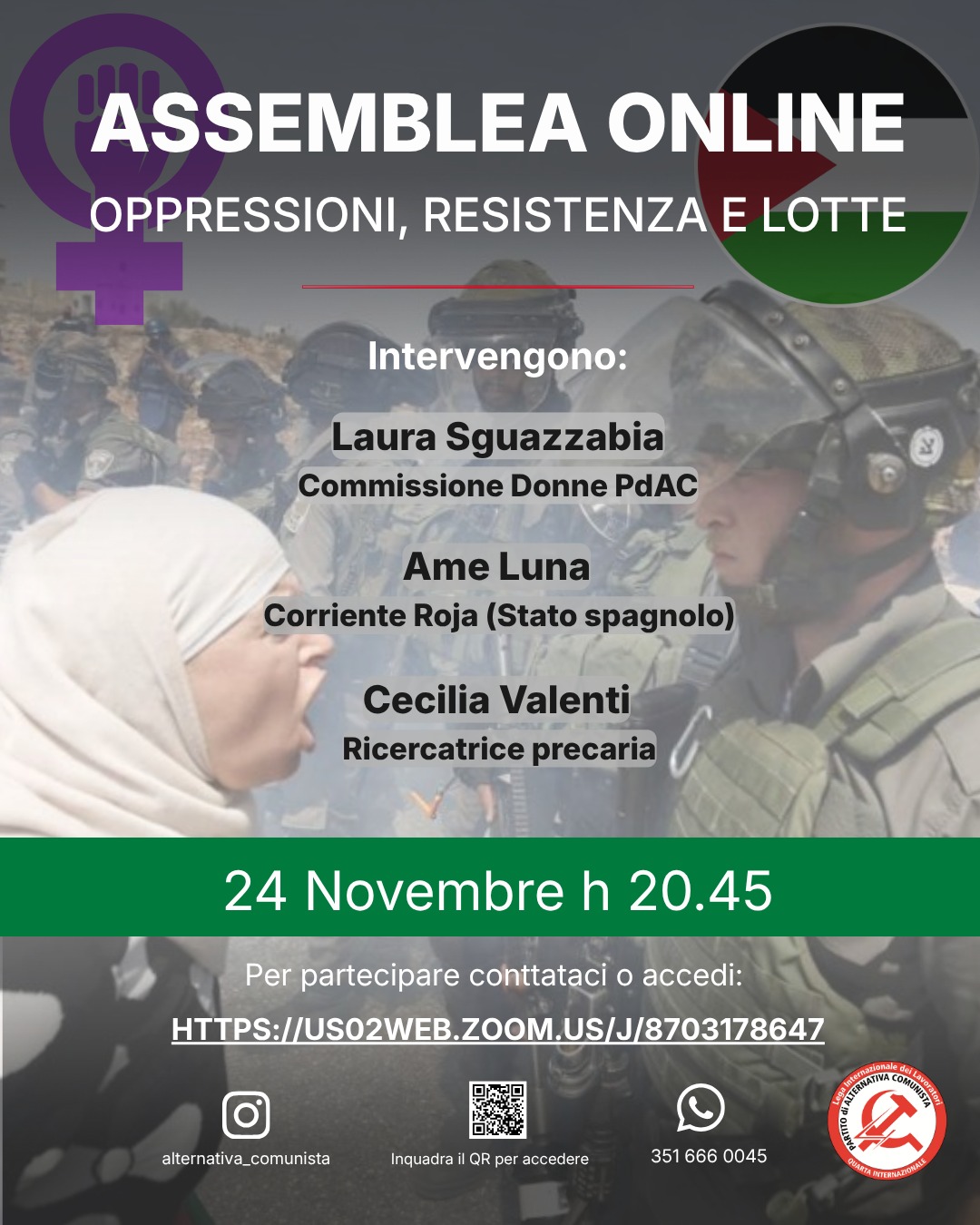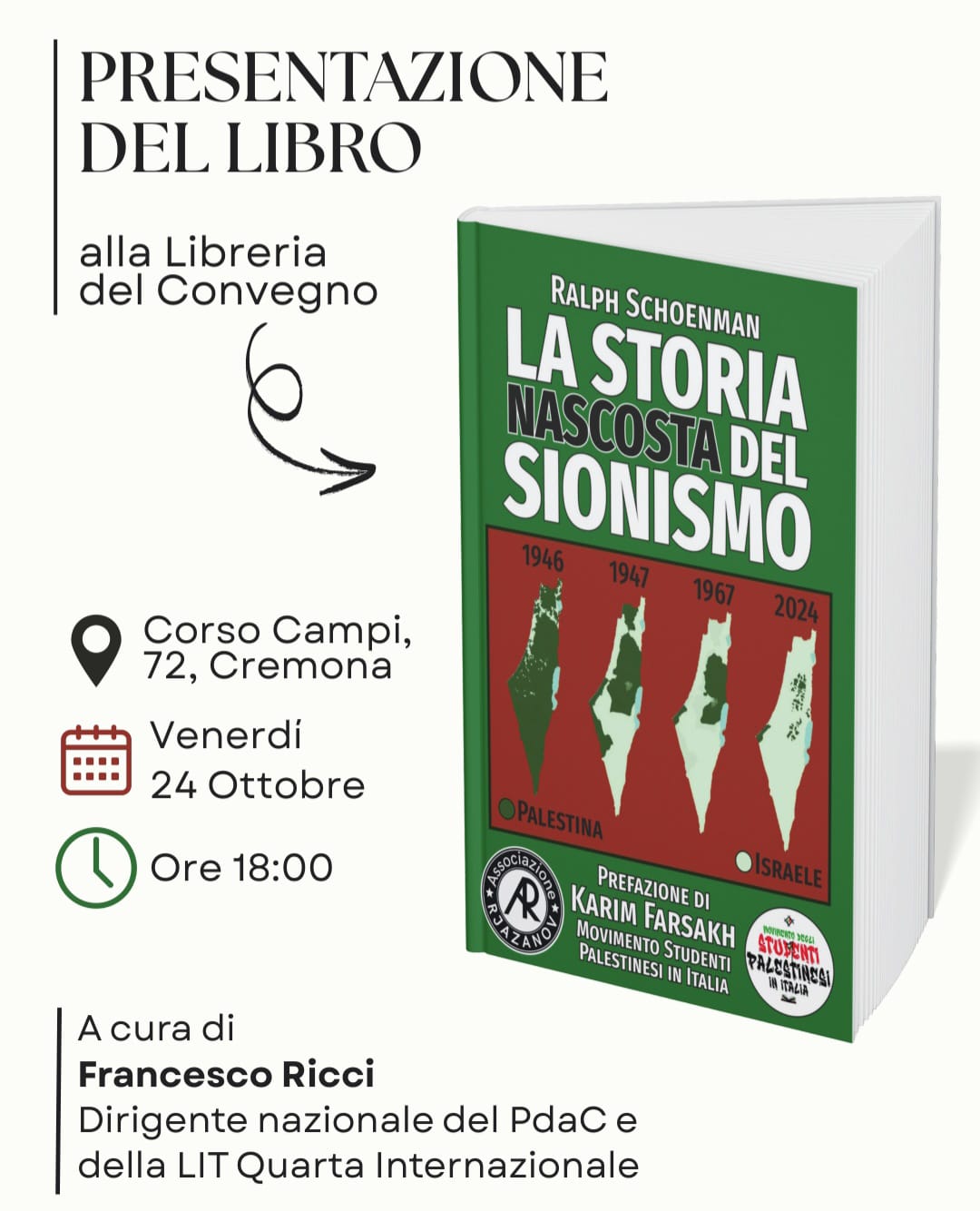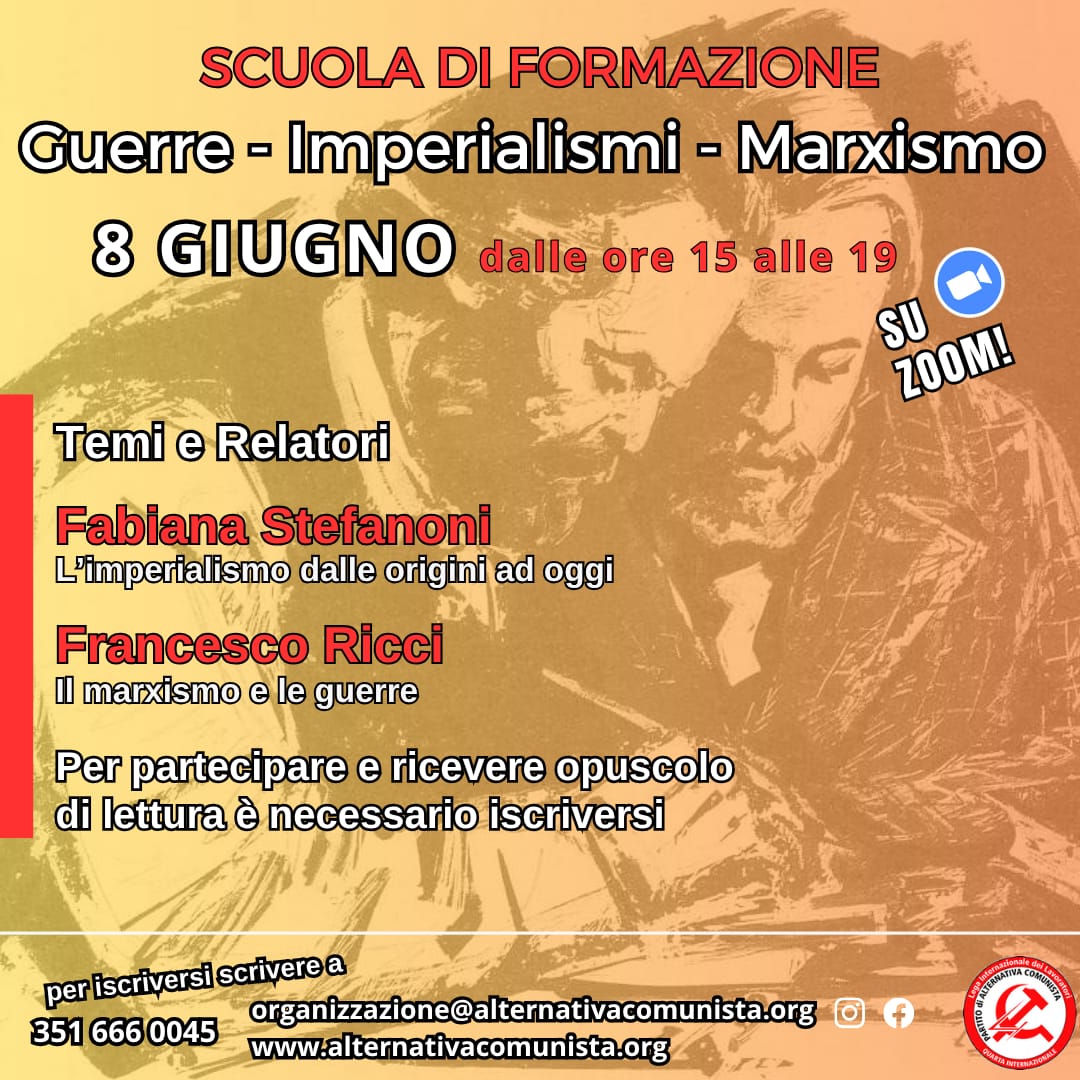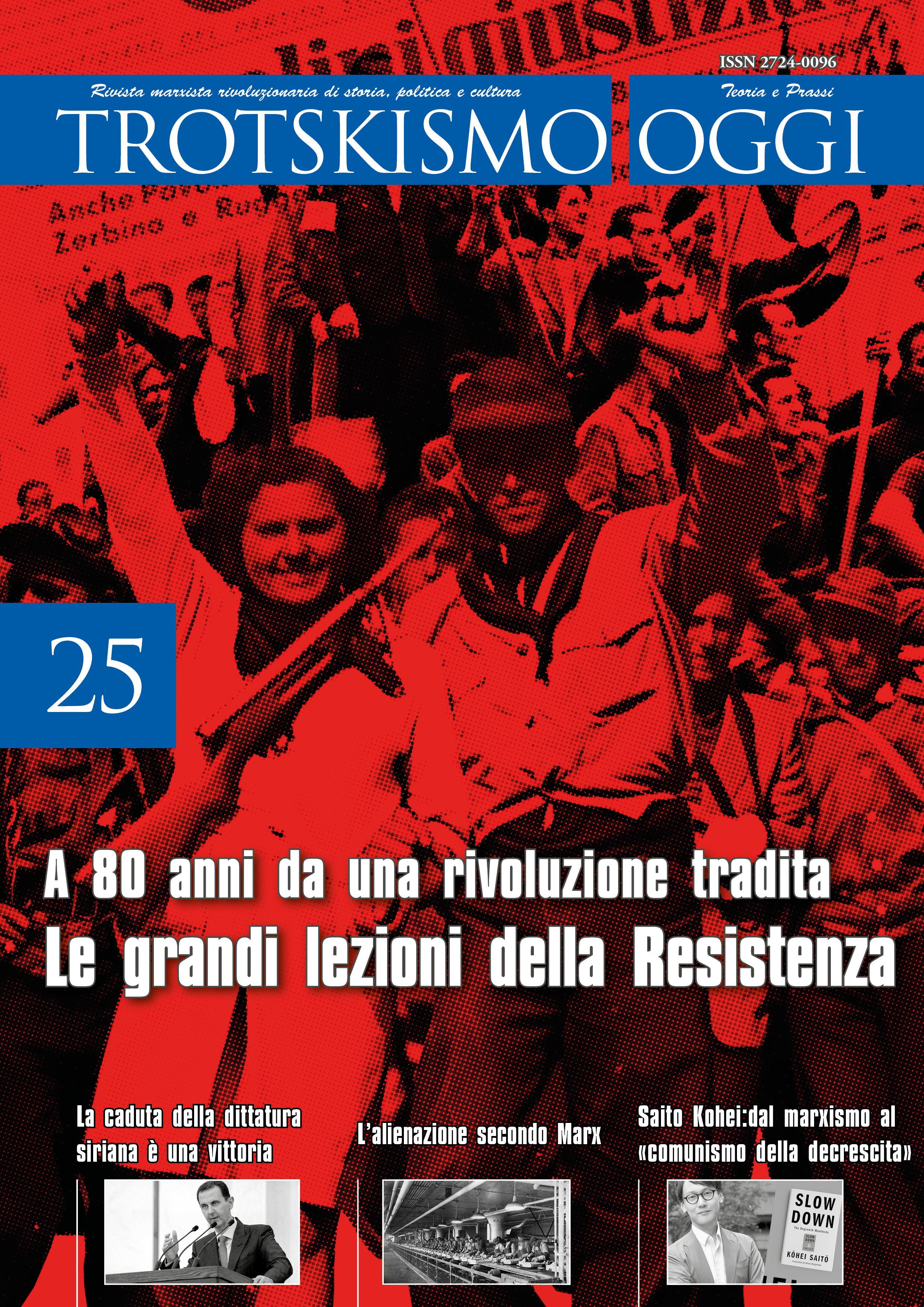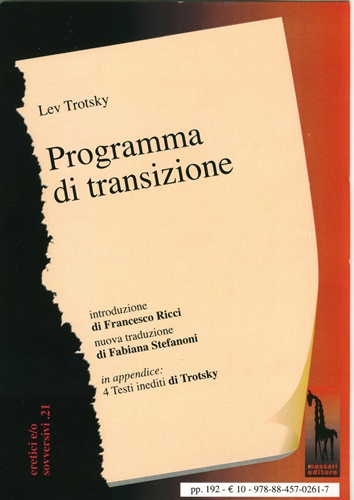Vivere e resistere in Cisgiordania
corrispondenza di Gabriel Biel
(dal sito della Lit-Quarta Internazionale)
Nel campo profughi di Bacqa (Giordania) i palestinesi conservano le chiavi delle loro case, delle moschee e dei loro negozi, perché credono che torneranno.
«La Palestina è una polveriera, dove l'idea di stabilità non esiste», dichiara il rapporto di una missione umanitaria in visita in Cisgiordania.
Noi
quindici brasiliani facenti parte della missione umanitaria approvata dal Forum
Sociale Mondiale di Tunisi abbiamo dovuto aspettare quattro ore per ottenere
l'autorizzazione ad entrare in Cisgiordania, dopo molti interrogatori ed
indagini sui nostri dati personali. Al posto di blocco di Allenby Bridge,
abbiamo vissuto la nostra prima esperienza negativa. Due dei nostri compagni,
di origine araba e attivisti della causa palestinese, non hanno avuto l'autorizzazione
per entrare. «Questioni di sicurezza» dichiara la giovane ufficiale
restituendoci i passaporti. A quel punto ci siamo resi conto che la missione
era iniziata e non sarebbe stata un giro turistico: stavamo entrando in
territorio occupato, in cui un Paese opprime apertamente un popolo intero,
violando quotidianamente i diritti umani ed una serie di risoluzioni delle
Nazioni Unite con lo sguardo complice della comunità internazionale. Il Paese
aggressore è Israele. Il territorio occupato è la Palestina.
Attraversare
il confine tra la Giordania e la Cisgiordania è il primo passo per chi vuole
entrare in Palestina da est, senza attraversare i territori occupati da Israele
nel 1948, durante la nakba. Il fiume Giordano e il Mar Morto sono le frontiere
naturali tra i due territori, ma ce n'è una terza, artificiale, costruita
dall'uomo, e che per milioni di palestinesi esiliati in Giordania è quella che
più intimorisce. Tra la frontiera della Giordania e i territori della
Cisgiordania, vi è un posto di blocco israeliano, anche se secondo gli accordi
di Oslo, la Cisgiordania dovrebbe essere amministrata dalla Autorità Nazionale
Palestinese (Anp). È la polizia di frontiera di Israele, che decide se si entra
o no in Palestina. Siamo passati dalla cordialità dei giordani alla freddezza
della polizia meglio addestrata del mondo. Gli Ufficiali israeliani sono
giovani che apprendono nelle scuole, nelle università israeliane e
nell'esercito –noto come Forze di Difesa Israeliane (IDF)– che i palestinesi e
i musulmani sono una minaccia per la loro stessa esistenza e, pertanto, devono
trattarli come potenziali terroristi.
Abu
Haitham è un signore palestinese di 77 anni, originario di Beit Jibrin, nei
pressi di Hebron, che è stato espulso con la sua famiglia quando aveva 13 anni
e, da allora, vive nel campo profughi palestinese di Bacqa, alla periferia di
Amman. Nella breve intervista che ci ha concesso, ha detto che, da giovane ha
partecipato alla resistenza palestinese e che ha fatto anche ricorso alle armi
in un dato momento, non perché gli piacessero i fucili e le granate, ma perché
la realtà gli impose di farlo. «Era l'unica maniera che avevamo per lottare» ci
ha raccontato con sicurezza il signore sorridente, con voce posata e viva,
vestito con una tunica arancione e un velo bianco sul capo: l'abito
tradizionale palestinese, indossato appositamente per l'occasione.
Eravamo
nella casa di Mohammad, il portavoce del campo, seduti sul pavimento, in un
salone ampio e pieno di cuscini. È stato un momento emozionante. «Non c'è un
solo giorno senza che pensi di tornare alla mia terra. E tornerò», ha esclamato
Haitham con gli occhi pieni di lacrime. Dopo la breve ma intensa intervista, ha
insistito per portarci a casa sua, dove vive da solo da quando morì sua moglie.
Ci ha mostrato orgoglioso l'albero genealogico della sua famiglia. «Raccontare
la mia storia è raccontare la storia di un popolo del quale vogliono cancellare
ogni e qualsiasi memoria», spiega. Uno dei miti più propagandati dagli ideologi
sionisti è che il popolo palestinese non era più che una manciata di tribù
beduine che vagavano nel deserto.
Sulla
strada per casa sua, abbiamo percorso le strette strade sterrate del campo di
Bacqa (Giordania), dove vivono migliaia di famiglie palestinesi. Il campo
somiglia molto a una favela brasiliana, piena di baracche e con poche
infrastrutture. All'ingresso del campo, una chiave, il simbolo della nakba
(catastrofe). I palestinesi conservano le chiavi delle loro case, delle loro
moschee, dei loro negozi, perché credono fortemente che un giorno torneranno.
Nel
novembre del 1947, l'ONU approvò la Risoluzione 181, che raccomandava la
creazione di due stati nella Palestina storica. Israele avrebbe mantenuto il
54% dei territori e agli arabi, discendenti di coloro che hanno sempre abitato queste
terre, sarebbe spettato meno della metà. Dalla fine del XIX secolo, si stava
dando una massiccia migrazione di ebrei in Palestina, stimolata dalle idee
sioniste che erano state accettate dalla grande borghesia ebraica e adottate
come versione ufficiale della storia degli ebrei. Durante la guerra del 1948,
conosciuta come nakba dagli arabi, tra ottocentomila e un milione di
palestinesi furono espulsi dalla loro terra. La maggior parte si stabilì nei
Paesi vicini: Siria, Giordania, Libano e Iraq.
Un regime di apartheid moderno
La
Cisgiordania è una terra bellissima, piena di montagne e valli, ricca di rocce
e paesaggi idilliaci. Il tipico paesaggio biblico delle greggi che pascolano
per la montagna è molto comune in queste terre. Qui si coltivano olivi, uva e
alcune verdure come lattuga e prezzemolo . L'acqua è scarsa, tanto per la
scarsità di piogge che per uno degli aspetti più crudeli dell'apartheid:
il controllo delle risorse idriche da parte di Israele, che detiene riserve
installate sul territorio palestinese, captando permanentemente l'acqua verso
le colonie, dove non manca e dove i giardini sono verdi e lussureggianti. Nei
territori palestinesi, il paesaggio è diverso, più arido e roccioso. Chi
fornisce l'acqua ai palestinesi è una società israeliana, la Mekorot, che la
vende ad un prezzo triplicato rispetto a quella delle colonie.
Altro
aspetto dell'apartheid riguarda la viabilità. Ci sono due reti di strade:
quella denominata bypass, strade ad accesso ristretto per
l'interconnessione degli insediamenti ebraici; e quelle ordinarie, condivise
tra israeliani e palestinesi. L'area degli insediamenti coloniali ebraici, le
basi militari, il sistema di strade e le aree demarcate per la futura costruzione
di ulteriori colonie assommano a più del 42% del territorio della Cisgiordania.
Già vi sono più di 380.000 coloni in Cisgiordania. I palestinesi della
Cisgiordania ammontano a 1,8 milioni di persone.
Tuttavia,
di tutte le pratiche di apartheid adoperate da Israele, la più crudele è
costituita dai check-point. Per recarsi da Ramallah a Gerusalemme, per
esempio, che distano 25 chilometri, bisogna attraversare il check-point di
Qalandia, uno dei più importanti e conosciuti. È come uscire o entrare in una prigione
di massima sicurezza. Il viaggio può durare da una a due ore in un “giorno
normale”. Abbiamo subito due controlli. L'accesso al posto di controllo avviene
attraverso dei corridoi delimitati da barre di metallo. Possono passare due o
tre persone alla volta, ogni due o tre minuti. Qui si respira una sensazione
surreale. Immaginate di dover vivere questa esperienza quotidianamente, come
nel caso dei palestinesi che vivono a Ramallah e lavorano a Gerusalemme. Oltre
ai posti di blocco, le incursioni dell'esercito israeliano sono all'ordine del
giorno, anche nelle zone A, amministrate dall'ANP.
La politica in un paese smembrato dall'occupazione
Mustafa
Barghouti, del partito Iniziativa Nazionale della Palestina, che vive a
Ramallah, ci ha spiegato come è suddiviso il territorio in Cisgiordania a
partire dagli accordi di Oslo (1992). «Abbiamo la zona “A”, sotto l'esclusivo
controllo delle Autorità palestinesi ; la “B” di competenza condivisa tra la
Anp e Israele, e la “C”, di esclusivo controllo israeliano». Barghouti fu
candidato presidente della Anp nel 2005 ed ottenne il 20% dei voti, finendo
secondo dopo Mahmoud Abbas. È membro del Consiglio Centrale dell'Organizzazione
per la Liberazione della Palestina (OLP), una coalizione di movimenti politici
creata dal Consiglio Nazionale Palestinese, nel maggio 1964, che riunisce la
maggioranza dei partiti e movimenti politici palestinesi. L'OLP sin dagli
Accordi di Oslo, soffre di un importante processo di logoramento per non essere
in grado, secondo il parere di un numero crescente di persone, di trovare una
soluzione alla questione palestinese.
Per
Nadia, una giovane attivista anticapitalista di Ramallah (non vuole rivelare la
sua vera identità), l'Olp collabora indirettamente all'occupazione. «Molti
politici della Olp traggono benefici dall'occupazione, da i fondi di Israele e
delle Nazioni Unite, mentre la popolazione palestinese deve affrontare una
realtà sempre più dura», riassume. Cresce la sfiducia verso i partiti politici
palestinesi compresi quelli più di sinistra, come il Fplp (Fronte Popolare per
la Liberazione della Palestina) e il Fdlp (Fronte Democratico per la
Liberazione della Palestina). Il Fplp è un gruppo armato molto attivo nella
Striscia di Gaza, che agisce all'interno dell'Olp e si presuma riceva
finanziamenti dall'Iran.
Nadia
ci ha ricevuto nella sua accogliente casa a Ramallah e abbiamo trascorso un po'
di tempo a parlare sul balcone, che gode di una ispirante vista sulle montagne
della città. La maggior parte delle città palestinesi, come Ramallah e Nablus,
sono nate nelle zone collinari pedemontane. La giovane venticinquenne inoltre
ci ha detto che pensa che la situazione, in questo momento, è di calma
apparente, ma che presto cambierà. «La Palestina è una polveriera, dove l'idea
di stabilità non esiste. Viviamo in uno stato di allerta costante». Ritiene,
inoltre, che in Palestina si verificherà qualcosa di simile a ciò che è
accaduto negli altri Paesi arabi, perché sussistono gli stessi problemi che in
qualsiasi Paese della regione. «La differenza è che viviamo in un regime di
segregazione totale a causa di una occupazione straniera che conta su
un'impressionante legittimazione internazionale».
Uno
dei problemi più sentiti dalla popolazione è la decomposizione del tessuto
sociale. La comunicazione tra i vari villaggi è molto scarsa, a causa dei posti
di blocco. La Palestina non ha continuità territoriale. Se in un villaggio si
organizza una qualsiasi manifestazione contro la costruzione del muro, per
esempio, Israele immediatamente chiude tutte le strade che vi danno accesso per
evitare che la notizia si diffonda e che la gente accorra in solidarietà.
Nello
stato attuale di cose cresce la disillusione. Un membro del Alternative
Information Center (AIC) di cui non possiamo rivelare il nome, ci ha detto che,
a parer suo, l'aumento delle alternative islamiste come Hamas, non solo a Gaza
ma anche in Cisgiordania, è dovuto alla crescente radicalizzazione religiosa
dello Stato di Israele. «Molti vedono in questi gruppi l'unica alternativa,
soprattutto dopo che la maggior parte dei partiti palestinesi non sono riusciti
a portare avanti la lotta contro l'occupazione. Siamo tutti stanchi dei
costanti abusi. Ancora ieri, un gruppo di coloni di Hebron ha distrutto, senza
alcuna motivo apparente, oltre un migliaio di alberi di olivo in terra
palestinese. Rendono la nostra vita un inferno. Vogliono espellerci da qui».
Come se non bastasse l'apartheid sociale ed economico, si pratica anche un
apartheid emotivo, una tortura psicologica permanente.
L'AIC
è un'organizzazione formata da palestinesi e israeliani che promuove la
giustizia, l'uguaglianza e la pace tra i due popoli. Per loro, l'unica maniera
di pacificare la regione è la fine dell'occupazione coloniale israeliana. Un
accordo di pace deve garantire il diritto all'autodeterminazione dei
palestinesi e il ritorno dei profughi.
A Hebron si concentrano tutti gli orrori dell'occupazione
Hebron
(al-Khalil in arabo) si trova a sud di Gerusalemme ed è una città santa, tanto
per i musulmani che per gli ebrei, perché ospita la Tomba dei Patriarchi o
Moschea di Abramo, dove si suppone siano sepolti, tra gli altri personaggi
delle mitologie ebraica, cristiana e musulmana, il profeta Abramo e sua moglie
Sara. Fu in questa moschea che il militante fondamentalista ebraico Baruch
Goldstein uccise 29 musulmani in preghiera davanti alla tomba, nel 1994.
Israele occupò la città nel 1967, durante la “guerra dei sei giorni”, e stabilì
un importante colonia ebraica nel centro della città.
Camminare
per la via del mercato di venerdì (giorno della preghiera per i musulmani) è
un'esperienza a dir poco angosciante. Non si incontra quasi nessuno salvo quei
pochi residenti e i soldati israeliani a guardia della strada che separa la
parte israeliana da quella palestinese. È come camminare in un ghetto. Si
tratta di una strada stretta, poco rumorosa, in cui si ode solo il rumore dei
passi dei soldati, armati fino ai denti, che camminano sempre in gruppi di
dieci o dodici. Non è consentito fare filmati o foto. Pochi negozi sono aperti
di venerdì e qui possiamo trovare sciarpe, foto, abiti tradizionali, camicie e
altri souvenir turistici. Passando attraverso il check-point che dà accesso
alla moschea, i soldati israeliani ci hanno detto sorridendo: “Welcome to
Israel”. Un sensazione di timore ci ha colti alla vista di questa giovane
aitante, con la mitragliatrice in spalla, che ci osservava con una apparente
calma. Il venerdì in genere è il giorno in cui ci sono più problemi, perché è
il giorno in cui i palestinesi sono soliti manifestare contro la distruzione
delle loro case e il furto della loro terra o per la liberazione dei
prigionieri politici. I soldati e i coloni israeliani passano tutto il giorno a
provocare gli arabi, il che è qualcosa di perverso.
Hebron
è divisa in Nord e Sud, e vi sono numerosi check-point, il più importante si
trova nella Sharea Al-Shuhada (Strada dei Martiri, in arabo). Dal massacro di
Hebron, la strada è chiusa ai palestinesi, essi devono fare un giro
lunghissimo, se vogliono passare dall'altro lato. La nostra guida ci ha detto
che, dal 2010, si organizza annualmente una manifestazione di protesta che
chiede l'apertura della strada ai palestinesi. In Palestina l'esistenza si
converte in resistenza.
La vita segue il suo corso
Vivere
sotto occupazione non è facile, soprattutto per noi abituati alle nostre
relativamente ampie libertà. Ciò nonostante, la maggior parte delle persone
tenta di condurre una vita il più possibile normale. Camminare per le strade di
Nablus nel tardo pomeriggio del giovedì, dopo la giornata di lavoro o di
scuola, incanta. È possibile vedere gruppi di 20 o 30 giovani scendere la
strada che viene giù dalla montagna, in direzione del centro della città, dove
ci sono la maggior parte degli spazi pubblici.
Nella
strada del mercato l'animazione è totale. Le grida dei venditori si mescolano
alle risate dei tassisti e ai clacson delle auto. Nel centro commerciale della
città, dove si trova l'unica sala cinematografica, che è stata una delle più
importanti della Palestina durante il periodo ottomano, decine di giovani vanno
a vedere le ultime pellicole in cartellone. I caffè e i ristoranti sono pieni
di gruppi di amici che fumano il narghilè o che prendono un tè rilassatamente.
In
questo raro momento di tranquillità, si sente al massimo il carattere pacifico
e amichevole del popolo palestinese. Un popolo che soffre qualsiasi tipo di
avversità ma che insiste nel cercare nella sua difficile esistenza le forze per
continuare a vivere, resistere e godere.
(Traduzione dall'originale spagnolo di Isa Pepe