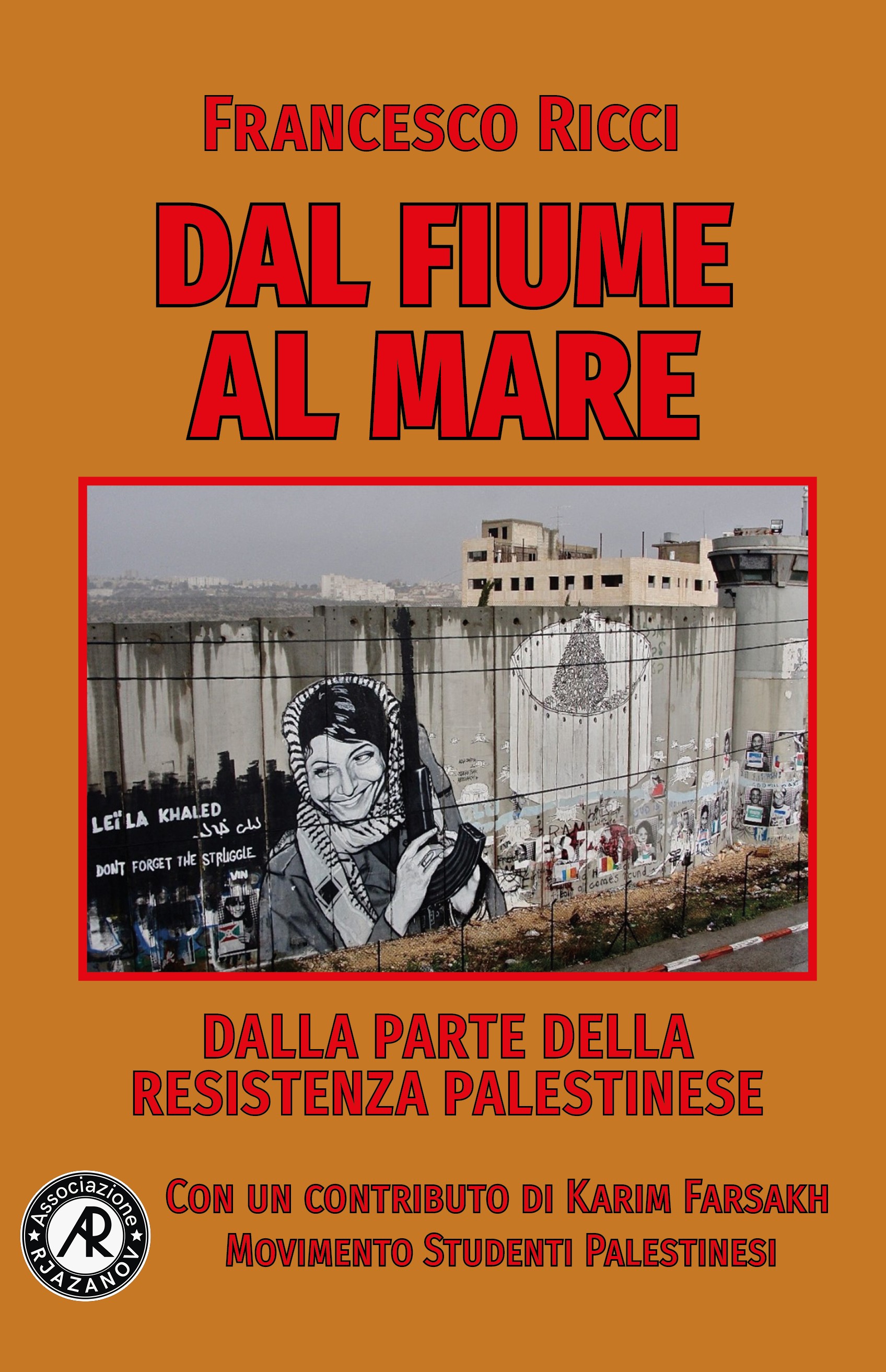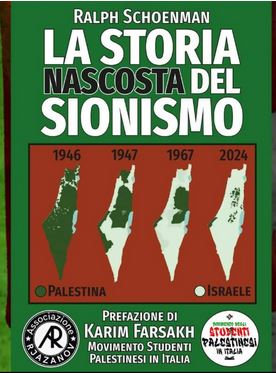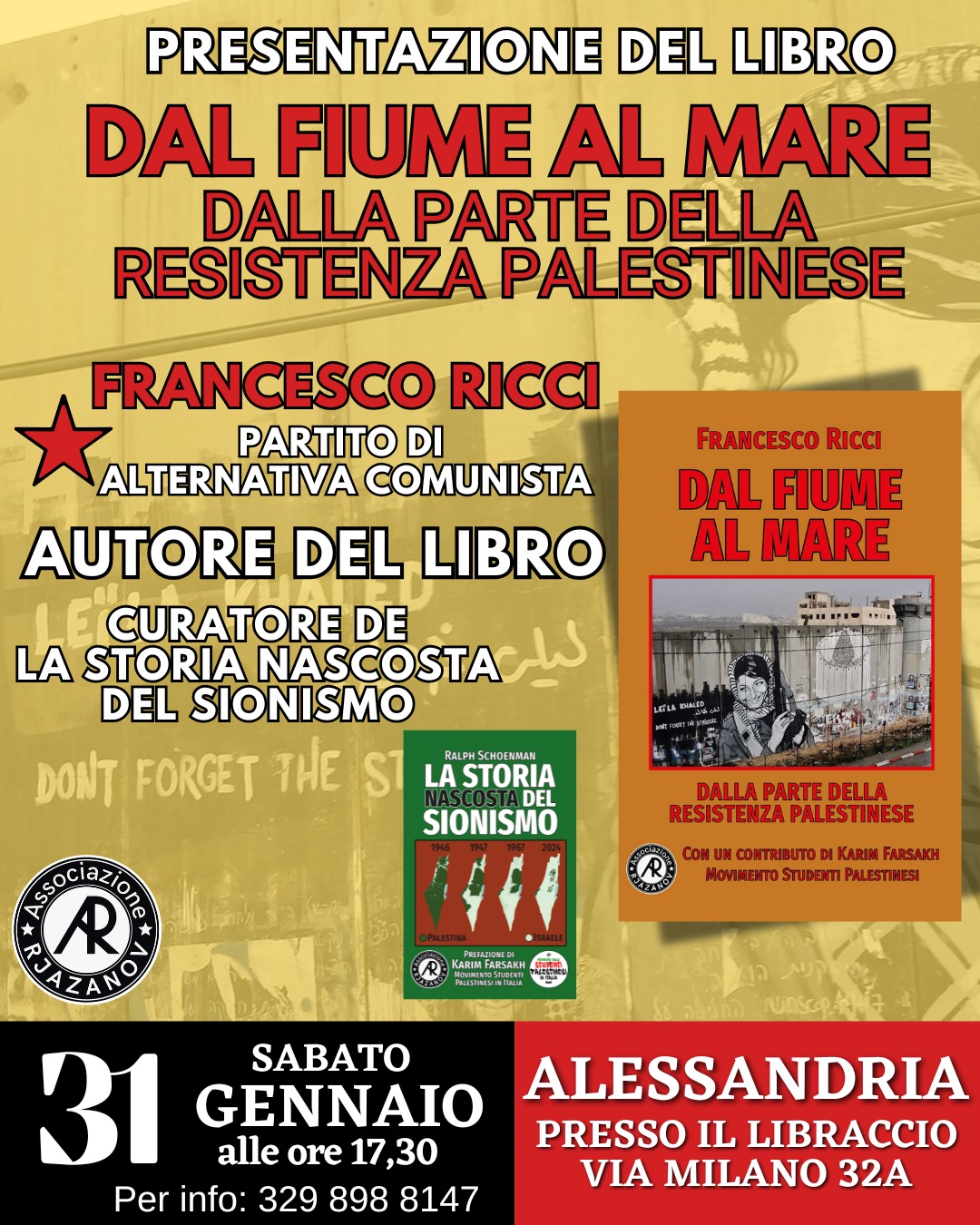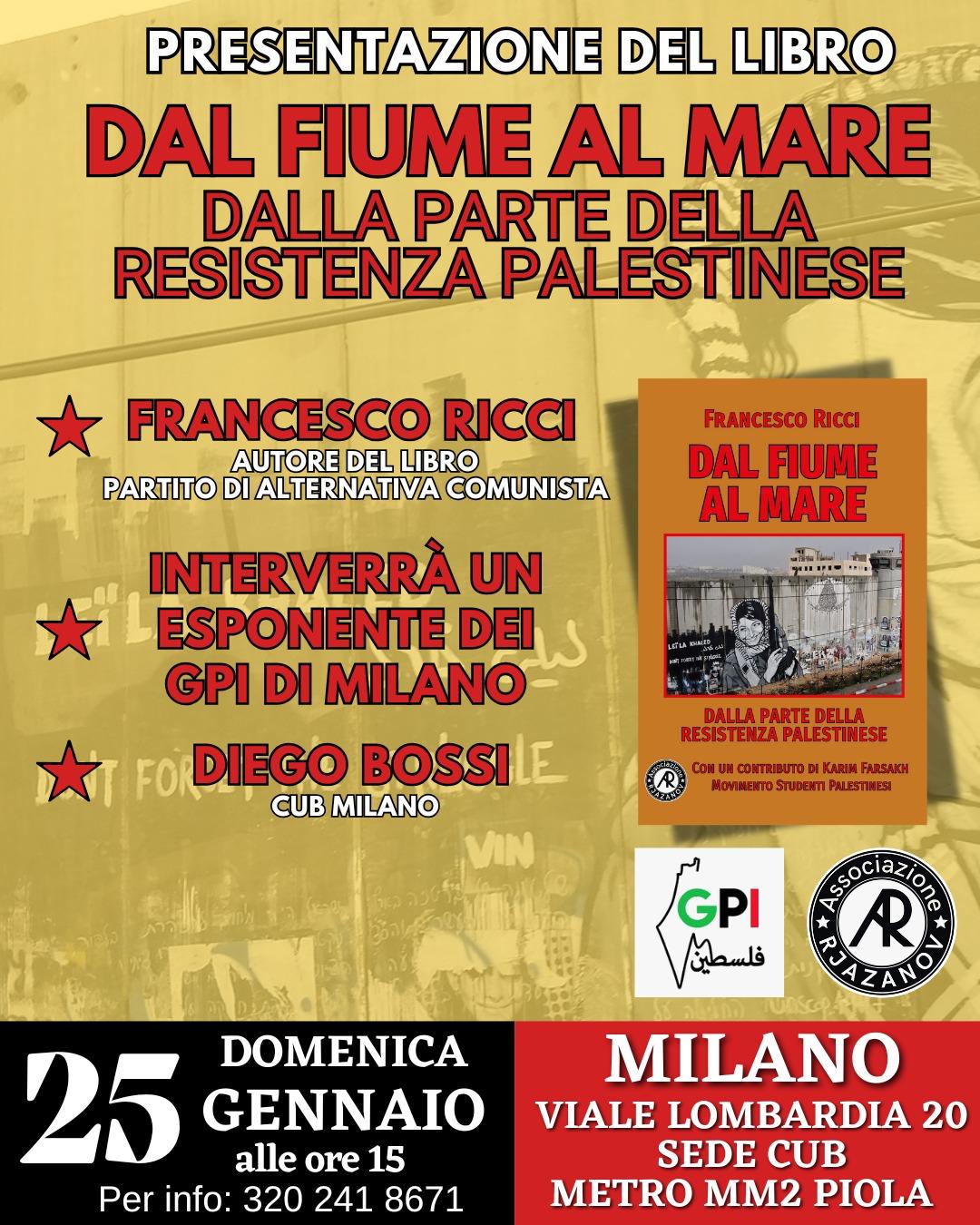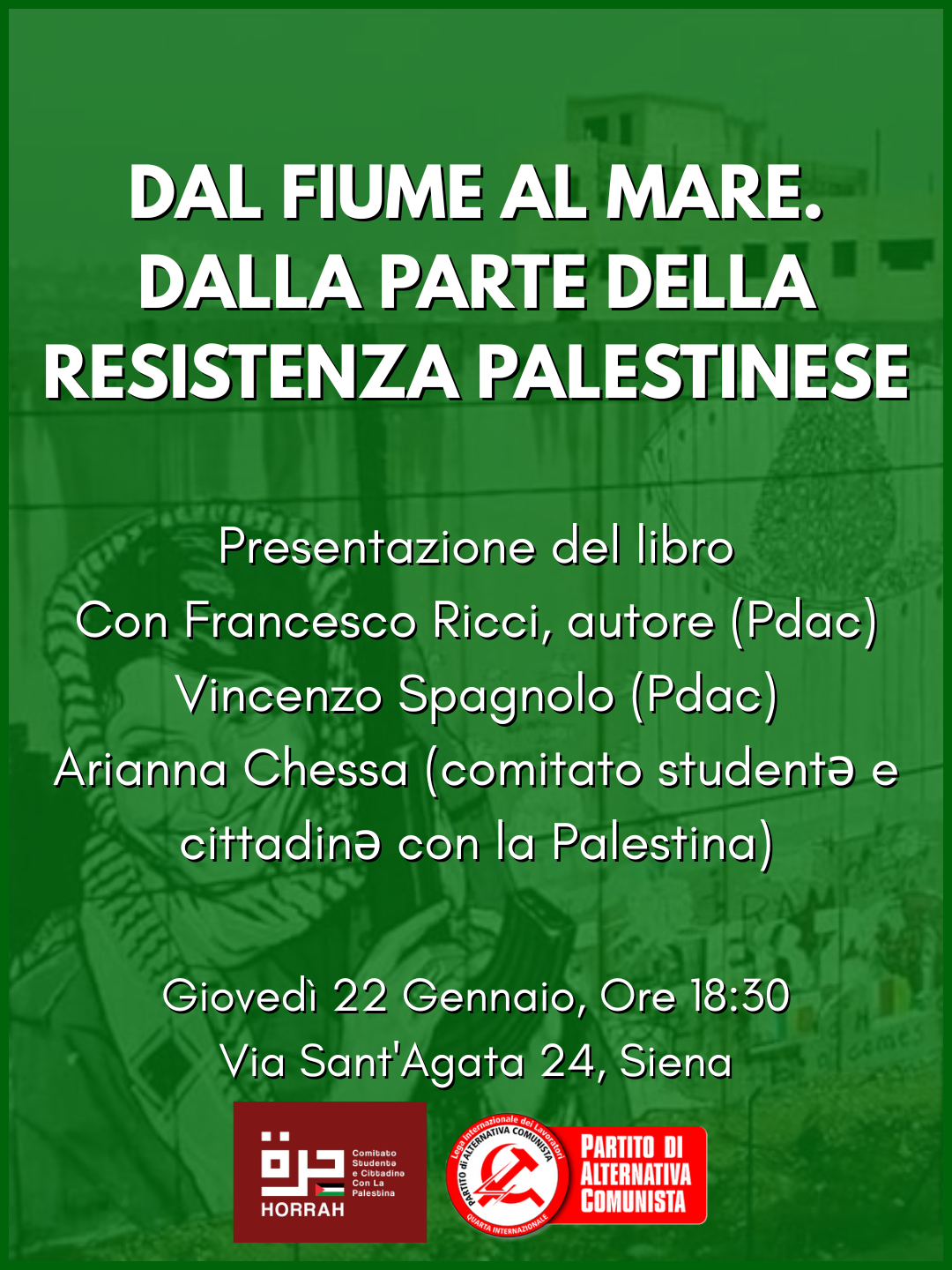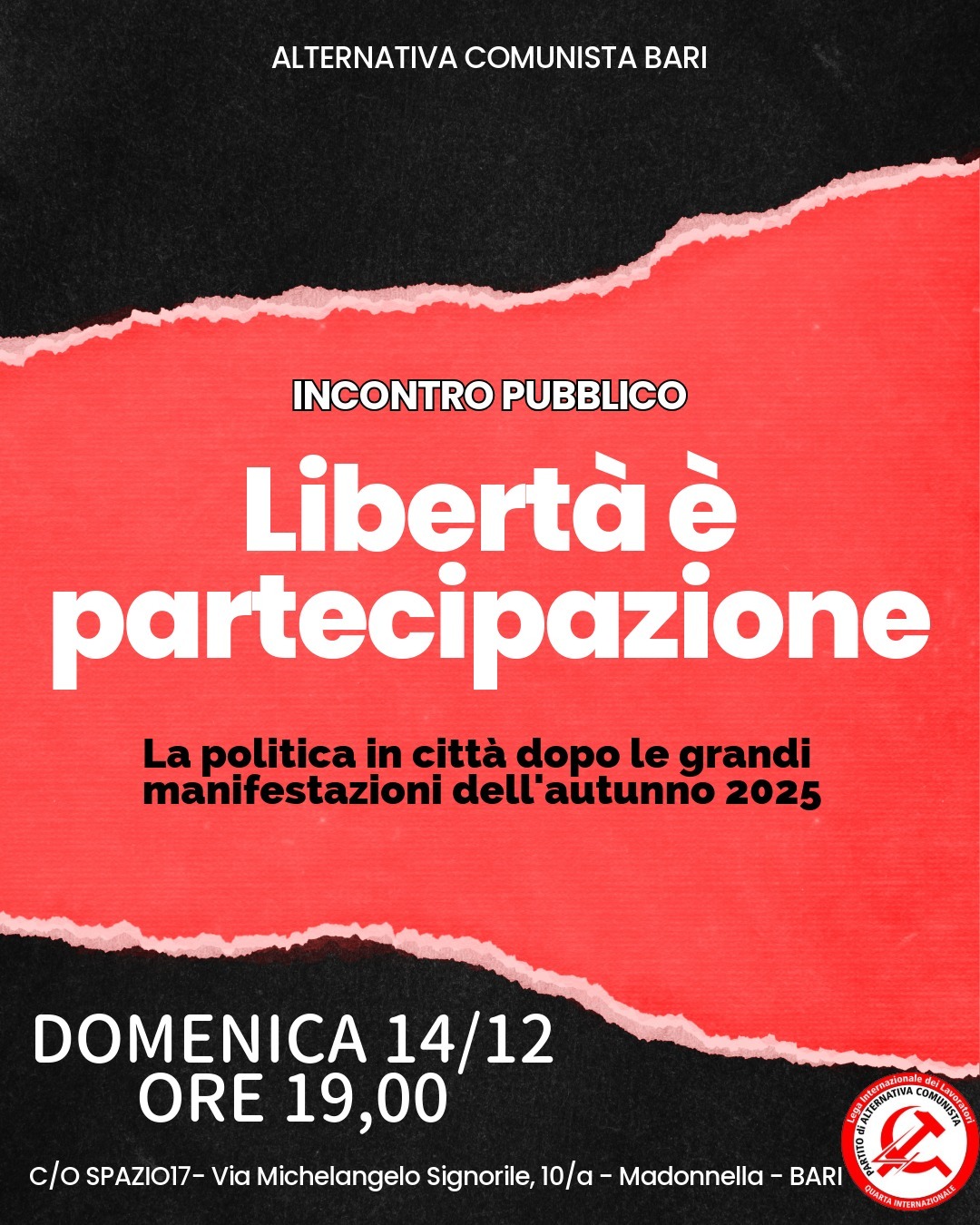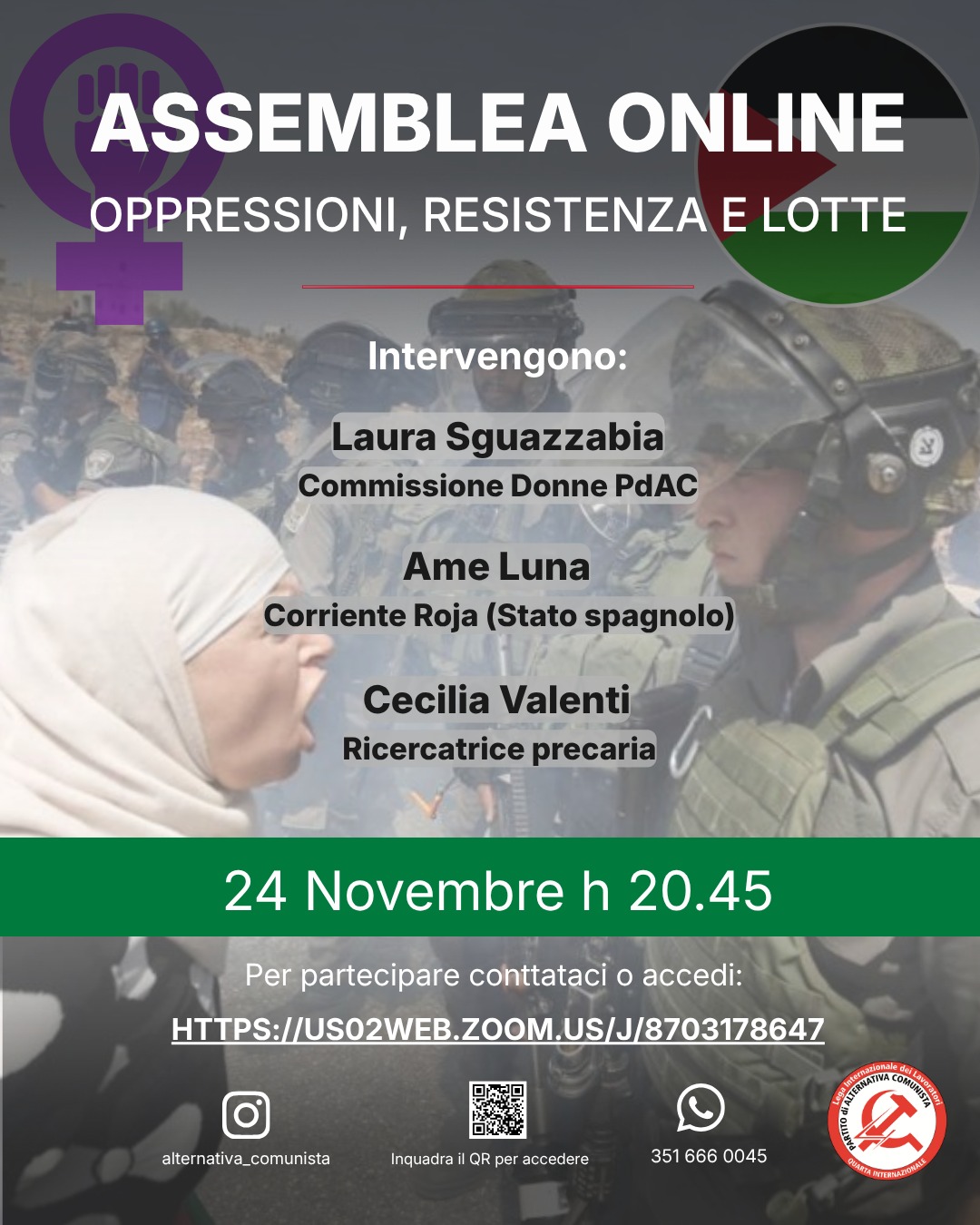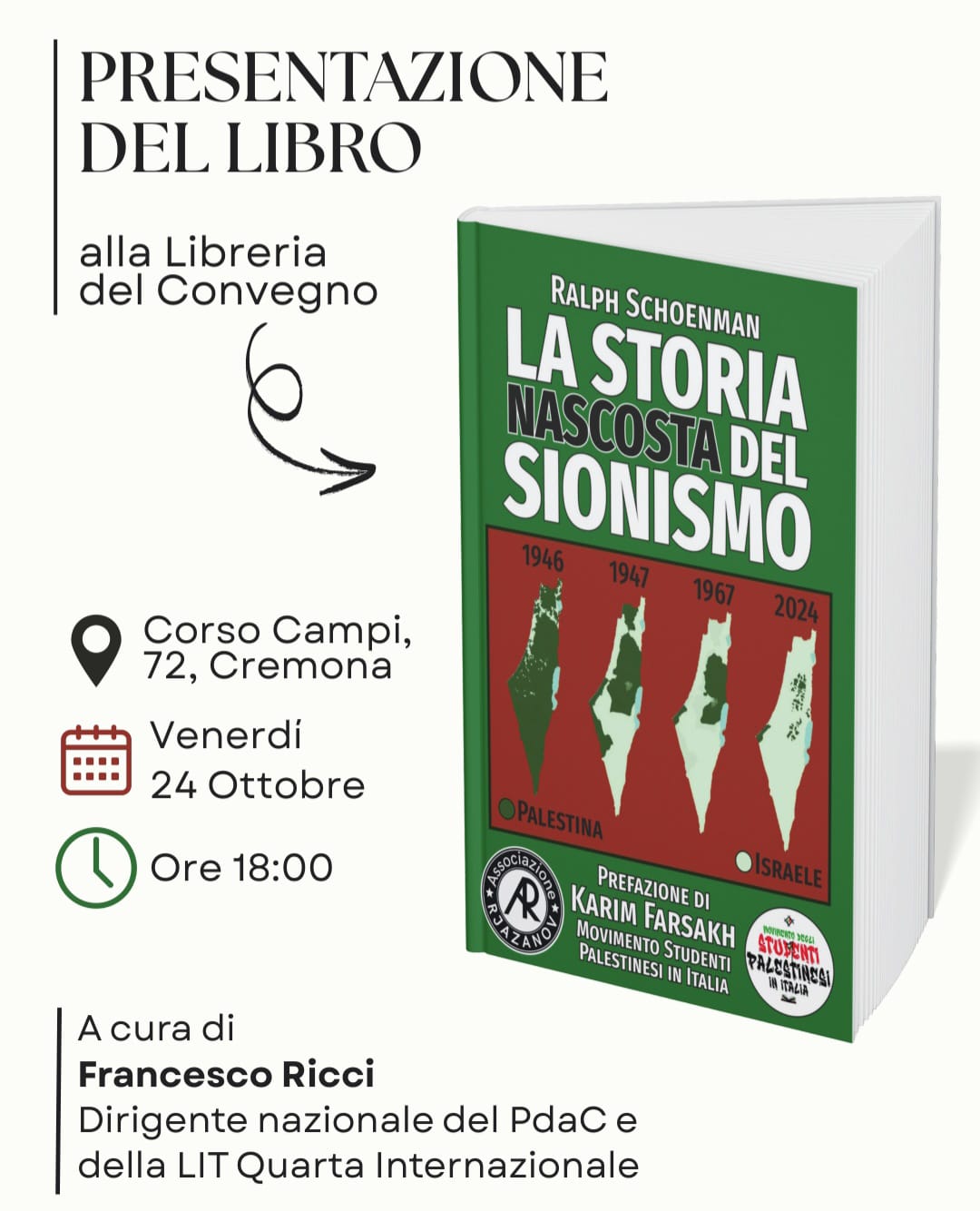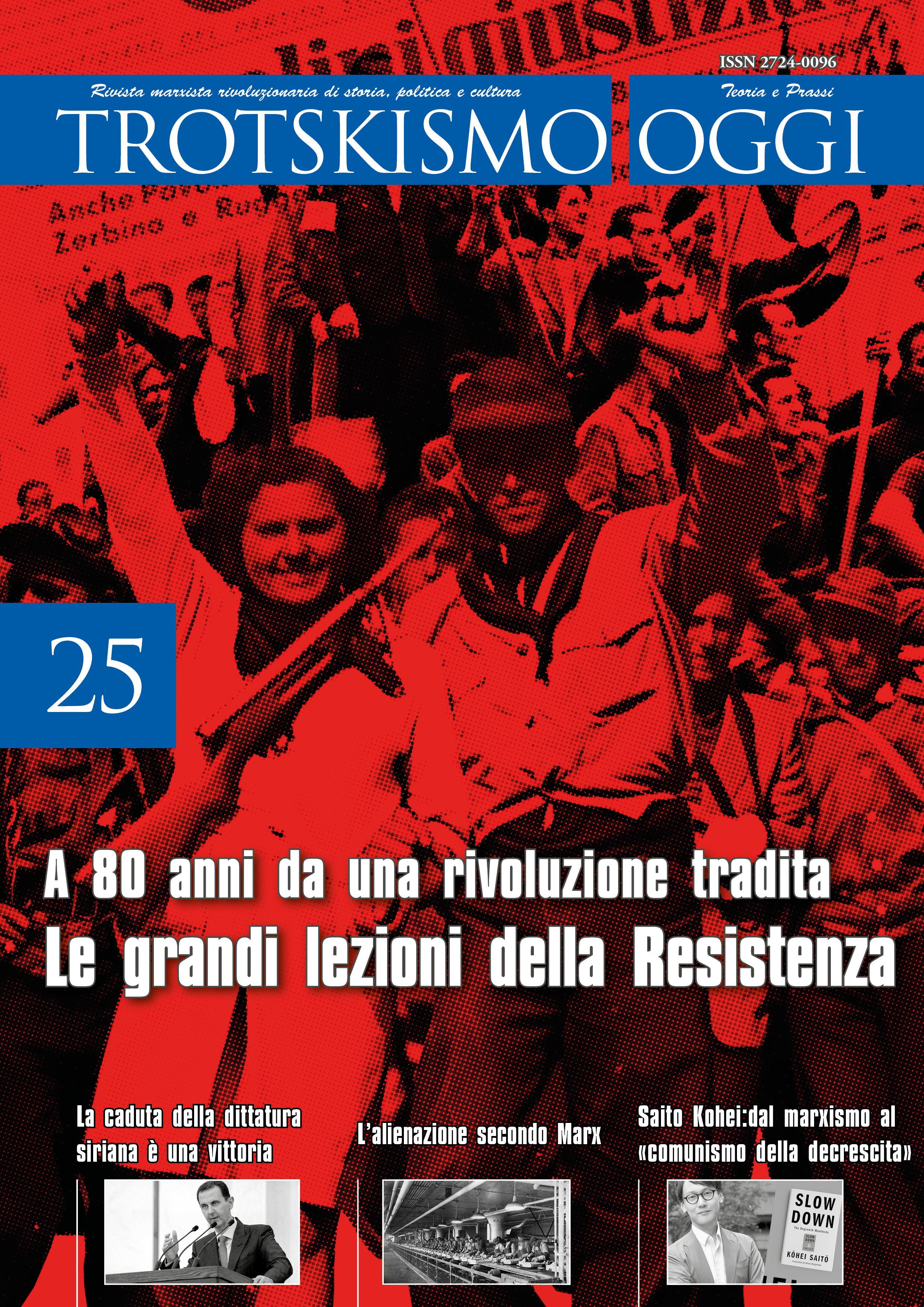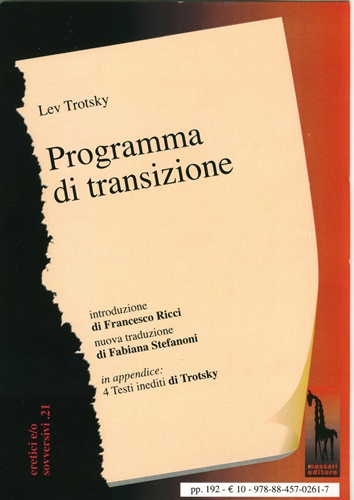Che cosa è il Pdac, per cosa lotta
1. Il capitalismo non offre un futuro all'umanità
Il modo di produzione capitalistico non è più in grado di offrire all'umanità nessuna prospettiva di progresso, esso è da tempo entrato nell'epoca del suo declino storico. La sua sopravvivenza anacronistica può avvenire solo al prezzo di continue guerre di rapina con cui i Paesi imperialisti si appropriano delle risorse dei Paesi dipendenti; con un crescente grado di sfruttamento dei lavoratori salariati degli stessi Paesi a capitalismo avanzato; con la sistematica distruzione delle risorse naturali. È in costante crescita la polarizzazione economica su scala mondiale tra Paesi avanzati e Paesi dipendenti; e, all'interno di ciascun Paese, tra i pochi che detengono immense ricchezze e i molti che sopravvivono con salari da fame. Tre miliardi di uomini e donne sono denutriti e non hanno accesso a cure mediche; un miliardo di persone non ha l'uso dell'acqua potabile né della corrente elettrica. La mortalità infantile è in costante crescita. Circa la metà della popolazione mondiale vive con meno di 2 dollari al giorno. Questo è il capitalismo.
Guerre militari (in prospettiva anche tra Paesi imperialisti), guerre sociali, miseria di massa, sfruttamento, razzismo, oppressione della donna: questi sono i tratti di un sistema la cui permanenza minaccia la stessa sopravvivenza del genere umano e del pianeta in cui abitiamo, sistematicamente distrutto per accrescere i profitti di qualche miliardario.
2. Il socialismo diviene sempre più una necessità storica innegabile
L’unico sistema che possa offrire di nuovo prospettive di crescita economica e culturale all’umanità è il socialismo, che, di fronte ad un capitalismo sempre più distruttivo, incapace di governare e risolvere le sue stesse crisi, che per permettere ai padroni di mantenere un elevato saggio di profitto sfrutta senza scrupoli i lavoratori e distrugge l’ambiente, mantenendo una sempre più irrazionale anarchia nella produzione, rappresenta sempre più chiaramente, come diceva Rosa Luxemburg, una necessità storica.
Il capitalismo però, nonostante il suo declino storico, non può perire da solo. Deve essere necessariamente abbattuto dall’azione cosciente del proletariato rivoluzionario che, guidato da un partito rivoluzionario di classe, prenderà il potere per creare un sistema produttivo pianificato, rispettoso della vita dei lavoratori e dell’ambiente in quanto non condizionato dalla ricerca del profitto privato e che grazie all’abolizione dello sfruttamento libererà immense forze produttive che miglioreranno in tutti gli aspetti la vita dei lavoratori di tutto il mondo.
Per raggiungere questo fine l’unico mezzo possibile è la rivoluzione proletaria.
3. Il capitalismo non può essere governato diversamente né riformato
Come sta dimostrando implacabilmente la presente crisi economica (che ha portato all'acme tutti i sintomi della malattia mortale del capitalismo e ha dimostrato che non esiste un capitalismo esente da periodiche e sempre più devastanti crisi), come dimostra il fatto che non vi è nessuna differenza sostanziale nelle politiche cosiddette di austerità portate avanti dai governi europei di centrodestra o di centrosinistra, non è possibile governare il capitalismo diversamente, in modo «più umano» o «progressista» o «onesto». Un sistema basato sulla divisione in classi, sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, sulla rapina delle risorse, non può conoscere stagioni differenti o differenti modi di essere. Al contrario: è proprio la permanenza del capitalismo, in qualsiasi variante di regime o di governo, a impedire in ogni Paese uno sviluppo socio-economico corrispondente alle attuali conoscenze scientifiche e tecnologiche.
Con l'applicazione tecnica delle conoscenze attuali l'uomo potrebbe essere liberato dall'alienazione del lavoro. L'impiego delle tecnologie moderne in una economia pianificata (e quindi sottratta all'anarchia economica capitalistica) consentirebbe già oggi di eliminare su scala internazionale la disoccupazione, di distribuire il lavoro tra tutte le forze disponibili, di ridurre a poche ore la settimana le ore lavorative necessarie per ogni uomo, lasciando l'uomo libero di realizzare le sue capacità individuali e collettive, sviluppando nuove relazioni umane nel quadro di una crescita culturale dell'intera umanità.
Il sistema attuale, invece, non può sopravvivere senza alimentare la disoccupazione; senza intensificare i ritmi di sfruttamento; senza accrescere l'alienazione e il suo corredo di malattie fisiche e psicologiche; senza contrapporre i proletari tra loro dividendoli e dominandoli per distinzioni di sesso e di etnia.
4. Il riformismo è un'illusione alimentata dalla borghesia
È proprio la dimostrata irriformabilità del capitalismo -dimostrata in due secoli e passa di storia- a condannare il riformismo per quello che è: solo una illusione e per di più un'illusione reazionaria perché alimentando credenze sulla possibilità di conquiste durature in questo sistema, senza infrangerne i confini, paralizza le lotte presenti, ne ostacola o devia una crescita rivoluzionaria.
In realtà, come ricordava Rosa Luxemburg, il riformismo non è un diverso percorso verso la stessa meta perseguita dai rivoluzionari: ma un altro percorso verso un'altra meta. Non una via di graduali riforme verso un sistema diverso, ma la finzione di modifiche, in realtà irrilevanti e transitorie, all'interno di questo stesso sistema irriformabile, con l'unico scopo di consentirne la sopravvivenza.
Gli unici a cui il riformismo porta un beneficio concreto sono i burocrati riformisti, cioè quelle schiere di parlamentari, funzionari politici e sindacali e uomini di apparato che fondano le loro fortune o i loro privilegi, piccoli o grandi, sulla conservazione dell'esistente. In questo senso tra riformisti e rivoluzionari non c'è una differenza di idee ma di interessi di classe. Per questo non si tratta di «unire la sinistra», cioè di unire riformisti e rivoluzionari, ma viceversa di rompere la sinistra, distruggere politicamente il riformismo per unire l'avanguardia della classe sotto la direzione dei rivoluzionari.
Tutto ciò è tanto più vero oggi, nell'epoca del riformismo senza riforme, della crisi brutale del capitalismo che ha condotto all'esaurirsi di ogni spazio per concessioni da parte dei padroni.
I governi «progressisti» si sono caratterizzati non tanto per l'introduzione di un «capitalismo dal volto umano» ‑ che non può esistere ‑ ma piuttosto per il tentativo di spezzare o prevenire la reazione delle classi subalterne coinvolgendo nel governo partiti operai e sindacati, per tentare (a seconda dei casi) di disarmare conflitti o di prevenirli imponendo una «pace sociale», che in regime capitalistico significa soltanto il disarmo politico e ideologico di una delle due parti (ovviamente quella degli sfruttati). Il riformismo resta dunque, per usare l'espressione di Lenin, l'«agenzia della borghesia nel movimento operaio».
In Italia, l'esperienza della partecipazione di Rifondazione e della sinistra governista al secondo governo Prodi (2006-2008), due anni segnati da una feroce politica anti-operaia privata (grazie al ruolo cuscinetto della sinistra governista e delle burocrazie sindacali, a partire da quelle della Cgil) di una efficace opposizione di massa, sono solo l'ennesima conferma dell'impossibilità di governare «diversamente» il capitalismo.
5. La lotta di classe non può essere fermata, va sviluppata in senso rivoluzionario
In una società divisa in classi nulla può impedire lo sviluppo di una lotta tra le classi. Certo non può impedirla la teorizzazione della «fine delle classi» o della «fine della storia». Per altro basta alzare lo sguardo da queste ridicole teorizzazioni (che pure hanno dominato la sinistra negli anni scorsi) per rendersi conto che anche laddove nessuno lo teorizza lo scontro di classe continua e talvolta divampa. La borghesia ha necessità, specie in fasi di crisi, di sfruttare di più i proletari; i proletari sono spinti a difendersi dall'attacco borghese. Lotte e rivoluzioni non sono un'eccezione ma la costante degli ultimi due secoli e tanto più della fase di crisi profondissima del sistema capitalismo che stiamo attraversando e in cui la parola Rivoluzione ha ripreso a echeggiare in ogni angolo del pianeta.
6. Per portare la lotta di classe fino in fondo serve il partito
Ma come dimostrano le lotte radicali e di massa in vari Paesi del mondo (Grecia, Francia, Usa, Marocco, Nepal ecc.) e le gigantesche mobilitazioni a sostegno della Palestina delle ultime settimane, la lotta delle masse, compresa la lotta rivoluzionaria, non basta. È necessario che nelle lotte si rafforzino e crescano dei partiti rivoluzionari in grado di dirigere l'avanguardia operaia e di influenzare le masse conducendole alla conquista rivoluzionaria del potere, all'instaurazione del governo dei lavoratori (dittatura del proletariato), punto di partenza della trasformazione socialista della società che può iniziare in un Paese ma può avanzare e realizzarsi solo su scala internazionale, passando attraverso la sistematica distruzione del sistema di divisione della società in classi e di sfruttamento del lavoro salariato, cioè del capitalismo, per costruire una società senza classi, in cui l'economia sia democraticamente pianificata in base alle esigenze dell'umanità, cioè il socialismo.
7. L'unico partito rivoluzionario è quello di tipo bolscevico, trotskista
Se l'intera storia del movimento operaio ha dimostrato che senza partito non vi è vittoria momentanea o duratura possibile, l'esperienza ha anche dimostrato che il partito necessario non è un partito qualsiasi ma deve essere un partito di tipo bolscevico, che cioè si fondi sui principi strategici del partito che condusse le masse alla vittoria nell'Ottobre 1917 e si basi sull'unico sviluppo coerente del marxismo dopo l'Ottobre, cioè il trotskismo: l'unica corrente del movimento operaio che ha retto la prova della storia ed è stata in grado di sopravvivere allo stalinismo senza trasformarsi in una setta sterile, senza confluire in una delle infinite varianti del riformismo, tutte subalterne alla borghesia e ai suoi governi anti-operai, all'imperialismo e alle sue guerre. Non si tratta di imitare esperienze del passato ma di riprenderne l'essenziale sviluppandolo concretamente nelle lotte presenti, nella situazione in cui viviamo. I principi fondamentali di un simile partito sono:
- la lotta per l'indipendenza di classe del proletariato dalla borghesia e dai suoi governi, assumendo come principio politico fondante l'indisponibilità a sostenere, direttamente o indirettamente, qualsivoglia governo nel capitalismo, ivi inclusi governi delle sole forze di sinistra ma basati, inevitabilmente fino a che permane questo sistema, sugli interessi della borghesia inconciliabili con quelli del proletariato;
- l'opposizione implacabile a qualsiasi governo all'interno nel capitalismo, inclusi i governi «progressisti» o «di sinistra» ecc., che vanno smascherati di fronte alle masse, contrastando ogni illusione nella collaborazione di classe e nelle istituzioni della falsa democrazia borghese;
- la lotta costante nelle organizzazioni del movimento operaio contro il riformismo e il centrismo, che in diversi modi impediscono lo sviluppo dell'indipendenza di classe;
- la lotta quotidiana, sulla base di un programma di tipo transitorio (che combini le rivendicazioni «minime» con quelle «massime»), in ogni ambito sociale, sindacale e politico per guadagnare la maggioranza negli organismi di lotta del movimento operaio, guidare l'avanguardia proletaria (cioè coloro che sono politicamente attivi e in lotta in un momento dato) verso i suoi obiettivi storici, trascinando più vaste masse verso la rivoluzione socialista;
- la lotta per costruire il partito su scala internazionale, come internazionale è l'unica realistica possibilità di costruire il socialismo. Questa lotta coincide ai tempi nostri con quella, in cui è impegnata la Lit e la sua sezione italiana, il Pdac, per rifondare la Quarta Internazionale, cioè un partito mondiale della rivoluzione socialista basato sul programma del marxismo rivoluzionario odierno, cioè del trotskismo;
- la lotta per organizzare questo partito come partito d'avanguardia, che cioè non mira a racchiudere al suo interno l'insieme della classe (né una sua maggioranza), ma al contrario accetta come membri militanti solo coloro che decidono di fare della militanza il compito principale della loro vita, accettandone implicazioni, compiti, sacrifici e impegnandosi lealmente e disciplinatamente in questo senso.
Perché questo progetto – il progetto comunista – possa svilupparsi e realizzarsi, sarà necessario il concorso di centinaia e di migliaia di militanti rivoluzionari. Oggi noi siamo solo a un primo stadio di questo lavoro: ma i possibili sviluppi della nostra costruzione nei prossimi anni e l'intervento attivo con un programma di obiettivi transitori all'interno dello scontro di classe che sta crescendo in relazione alla crisi del capitalismo potrebbero offrirci una possibilità concreta di compiere, in poco tempo, dei passi avanti molto lunghi.
Nella lotta a morte tra il capitalismo e il socialismo, tra la controrivoluzione e la rivoluzione, non esistono angoli riparati per nessuno: bisogna schierarsi. Questa è la proposta che avanziamo a tutti i militanti comunisti che vogliono contribuire a risolvere la crisi storica dell'umanità e che in questa nostra epoca di guerre, crisi e rivoluzioni vogliono partire dal compito immediato: il processo -lungo, difficile ma indispensabile- di costruzione nel vivo delle lotte di un partito comunista per fare la rivoluzione e prendere il potere.
In questo testo ci ripromettiamo di illustrare sinteticamente (e schematicamente) la storia del Pdac e quali sono i principi politico-programmatici strategici che pone alla base del proprio agire. Lo scopo di questo testo è introdurre alla conoscenza generale del Pdac i compagni e le compagne che per la prima volta si avvicinano al partito.
Elementi di strategia dei rivoluzionari
1) I rivoluzionari e la lotta per il potere
Il compito fondamentale dei comunisti resta ancora oggi quello espresso nel Manifesto di Marx ed Engels: guadagnare la maggioranza del proletariato, nel corso delle sue lotte quotidiane, alla comprensione dell'impossibilità di riformare il capitalismo e alla conseguente necessità di conquistare il potere politico attraverso il rovesciamento dell'ordine borghese. Solo la trasformazione del proletariato in classe dominante (cioè la dittatura del proletariato) potrà aprire una strada di progresso per l'umanità che conduca infine all'eliminazione della società divisa in classi e alla cancellazione di ogni forma di oppressione.
La rimozione della teoria marxista dello Stato si accompagna sempre con la riacquisizione delle teorie riformiste (spesso presentate come una «novità» contrapposta al «vecchio», alle «teorie novecentesche»). La differenza tra riformisti e comunisti non è una differenza di percorsi per arrivare a una nuova società (da una parte la via pacifica, legale del riformismo; dall'altra quella demodé della rottura rivoluzionaria) La questione dell'atteggiamento verso lo Stato ha sempre costituito un discrimine tra riformisti e rivoluzionari.
Non è un caso che proprio a questo tema Lenin dedicò il suo libro più importante (Stato e rivoluzione), scritto nel corso della rivoluzione del 1917 per riarmare teoricamente il partito bolscevico e prepararlo all'Ottobre. Lo fece ristabilendo la reale dottrina di Marx ed Engels, ripulendola dalle incrostazioni revisioniste. Oggi noi dobbiamo fare lo stesso lavoro ma raddoppiato, perché oltre alle falsificazioni dei riformisti si sono aggiunte quelle dello stalinismo. Non si tratta di tornare al «Verbo» ma di capire come nelle posizioni leniniste (e prima in quelle di Marx) si rispecchiano le lezioni dell'intera esperienza storica del movimento operaio. Per il marxismo lo Stato è il prodotto dell'antagonismo delle classi. Non è cioè un'entità «neutra» bensì uno strumento di parte, che serve a imporre il dominio di una classe su un'altra; lo strumento grazie al quale la classe dominante conserva il controllo dei mezzi di produzione. Il potere dello Stato (da quello democratico-parlamentare alla dittatura militare e al fascismo) si fonda su «gruppi di uomini armati» (polizia, esercito), e sui guardiani (magistratura, carceri) di una legislazione corrispondente agli interessi della classe dominante. Il fatto che lo Stato non sia neutrale nello scontro tra borghesia e proletariato comporta l'impossibilità di «conquistarlo» (magari attraverso una vittoria elettorale) per «convertirlo» a un uso diverso. Se a determinati rapporti di proprietà e produzione corrisponde una specifica struttura statale, allora il proletariato che cerca di rovesciare quei rapporti necessita di uno strumento affatto diverso. Ne consegue che i comunisti si danno come obiettivo quello di infrangere lo Stato: «spezzarlo», secondo la formula che Marx analizzò nell'esperienza della Comune di Parigi del 1871 che costituiva appunto «la forma finalmente scoperta» attraverso cui i lavoratori potevano esercitare il loro dominio, unendo in un unico organismo il potere legislativo ed esecutivo. Spezzare lo Stato, dunque, attraverso una rivoluzione (peraltro è questo l'unico senso che può avere la parola, salvo riferirsi al moto dei corpi celesti) e sostituirlo con un altro Stato, un altro dominio: al posto della dittatura della classe borghese (esercitata da pochi uomini sulla stragrande maggioranza), la dittatura del proletariato (esercitata dalla maggioranza della popolazione contro una esigua minoranza). Una dittatura, certo, perché solo in questo modo una rivoluzione può difendersi dai tentativi della borghesia di riprendersi il potere; ma una dittatura che a differenza di tutte quelle conosciute nella Storia mira a estinguersi, insieme con l'estinzione della società divisa in classi.
L'essenziale dell'insegnamento della Comune (che fu sconfitta per l'assenza di un partito marxista), cioè la rivoluzione per «spezzare» lo Stato e sostituirlo con una dittatura operaia, fu indicato dall'Internazionale Comunista dei primi anni (prima dello stalinismo) come fondamento programmatico valido per i partiti comunisti di tutto il mondo, a prescindere dalle differenze esistenti tra un Paese e l'altro. Gli insegnamenti delle due «Comuni» (quella perdente di Parigi e quella di Pietrogrado, vincente perché diretta da un partito marxista) furono condensati nelle Tesi dell'Internazionale sul parlamentarismo, mentre fu respinta ogni teoria volta a presentare questi assi cartesiani come prodotto di una inesistente «specificità russa» a cui contrapporre una «rivoluzione in Occidente» – intesa come graduale riforma dello Stato per i Paesi a capitalismo avanzato. La concezione marxista dello Stato e della rivoluzione non significa (a differenza di quanto si vuole far credere con certe caricature) una passiva estraneità agli strumenti della democrazia borghese in attesa di un messianico evento rivoluzionario. Per i marxisti la rivoluzione va preparata anche usando le istituzioni borghesi, cioè le elezioni e i parlamenti. Ma – e qui sta la differenza con i riformisti – i comunisti partecipano alle elezioni per fare propaganda al programma rivoluzionario e stanno in quelle aule per prepararne la distruzione. Se eletti in assemblee rappresentative agiscono non come legislatori tra i legislatori ma come propagandisti di un'altra democrazia; in questo senso la loro partecipazione alle istituzioni che è secondaria rispetto alla battaglia principale nei luoghi di lavoro, nei sindacati, nei movimenti. I comunisti, che pure partecipano – se possibile – alle assemblee rappresentative, non possono per nessun motivo far parte dei governi di qualsiasi grado. Non per ossequio a qualche «comandamento» marxista ma perché – come l'intera esperienza storica ha dimostrato – l'opposizione a ogni governo borghese è il requisito indispensabile (ancorché non sufficiente) per liberare le masse dalle illusioni in uno Stato e in una Democrazia «al di sopra delle parti», riformabili e riempibili a piacimento di contenuti di classe diversi.
Ecco dunque che l'opposizione a ogni governo borghese è l'unica strada attraverso cui far arrivare i lavoratori a un programma di indipendenza di classe e per questa via costruire - sulle macerie del capitalismo- l'unico governo in cui possano entrare i comunisti: un governo dei lavoratori per i lavoratori. La battaglia contro la partecipazione ai governi nel sistema capitalistico ha per questi motivi sempre costituito il mezzo per liberare le masse dall'influenza dei riformisti che (ecco il senso dell'espressione leniniana: «agenti della borghesia nel movimento operaio»), cercano di convincere con la loro azione la classe operaia dell'inutilità di prendere il potere e quindi la subordinano ai governi (e agli interessi) della borghesia.
L'opposizione di principio, su cui si è fondata l'Internazionale comunista, è stata poi sostituita dagli stalinisti che (a partire dal VII Congresso del 1935) hanno reintrodotto nel movimento operaio il morbo governista e teorizzato la possibilità dei comunisti di partecipare a governi nel capitalismo. In realtà non esiste conciliazione possibile tra gli interessi dei lavoratori e quelli dei padroni e ogni tentativo di dimostrare il contrario lo ha confermato: non c'è stato un solo caso in cui i lavoratori hanno goduto di benefici - fossero pure minimi e immediati - per la presenza di loro rappresentanti in governi costituiti nel sistema capitalistico. Anzi: ognuna di queste esperienze si è rivelata una sconfitta e spesso una tragedia: dalla partecipazione di Blanc al governo nel 1848, passando per i fronti popolari degli anni Trenta; dalla collaborazione di governo dei comunisti europei nel secondo dopo-guerra ai governi di «unità nazionale» degli anni Settanta; dal cosiddetto «esperimento cileno» di Allende ai «governi di sinistra» in Francia a fine anni Settanta inizio anni Ottanta; dal primo governo Prodi in Italia al governo Jospin in Francia; e poi ancora dal «modello Lula» in Brasile ai governi di centrosinistra in Sudafrica; fino al secondo governo Prodi... La lista è lunghissima ma non c'è un solo caso positivo per i lavoratori: mentre in ognuno di questi casi la borghesia si è rafforzata imponendo le sue politiche e indebolendo le reazioni della classe operaia, asservita al carro padronale. Così come la socialdemocrazia odierna (ad esempio quello che rimane di Rifondazione) riparte dalle teorie governiste dei riformisti e dello stalinismo, così il comunismo non può anche oggi che ripartire dalla teoria del rifiuto di ogni collaborazione di governo con la borghesia. Se un partito che si definisce comunista abbandona il ruolo di opposizione ed entra in un governo borghese, abbandona il compito principale dei comunisti. Lo stesso si può dire di quei partiti che si definiscono comunisti e che invece di spiegare alle masse la natura di classe dello Stato e dei suoi apparati repressivi, spargono illusioni «nonviolente». In ogni Paese abbiamo visto in questi decenni in azione quelle «bande armate a difesa del capitale» di cui parlava già Engels, costituite dalle varie polizie ed eserciti, ufficiali e clandestini (v. Gladio), il cui unico scopo è appunto quello di difendere lo Stato della classe sfruttatrice dall'assalto futuro della classe sfruttata. Questo è particolarmente evidente nelle manifestazioni di piazza e nelle lotte operaie ma gli organi repressivi dello Stato borghese non operano solo in questi casi: ad es. i servizi segreti sono attivi per cercare di stroncare sul nascere le lotte e lo stragismo che l'Italia ha conosciuto nella sua storia, messo in atto dai servizi segreti (per nulla «deviati» ma operanti su istruzione dei governi), con l'utilizzo di manovalanza fascista, è stato la manifestazione più visibile di un lavorio sotterraneo costante volto contro la crescita delle lotte, a tutela del sistema capitalistico.
Le teorie «gandhiane» sono dunque incompatibili con il comunismo perché non fanno i conti, per l'oggi, con la necessità di autodifesa di ogni lotta e rimuovono, per il domani, il problema della violenta resistenza che le classi dominanti opporranno a ogni tentativo di espropriarle.
Un'impostazione, quest'ultima, non certamente frutto di un'improvvisazione, poiché la storia del comunismo conseguente si è mossa costantemente su questo terreno: Marx ed Engels nella Prima Internazionale fecero una dura battaglia per il ritorno al Manifesto del partito comunista; Lenin e Rosa Luxemburg dalla sinistra della Seconda Internazionale, in forma certamente creativa e innovativa (si pensi al concetto di imperialismo e allo sviluppo della teoria leniniana sul partito e sulla questione nazionale), fecero una consistente battaglia per il recupero del vero Marx contro tutte le deformazioni revisionistiche, riformiste e centriste: senza quel recupero dei fondamenti marxisti non sarebbe nato il partito bolscevico come partito dirigente della rivoluzione di ottobre; così come l'Opposizione di sinistra delle origini e successivamente la Quarta internazionale solo recuperando i fondamenti, che la socialdemocrazia e lo stalinismo avevano distrutto, attualizzarono il marxismo.
2) Il partito d'avanguardia leninista
La classe operaia non è «scomparsa» e non può scomparire perché senza di essa non esisterebbe il capitalismo. Anche la lotta di classe non è scomparsa (e anzi in questo periodo di crisi economica tende ad esacerbarsi) e non può scomparire finché esisterà una società divisa in classi in scontro tra loro perché animate da interessi vitali inconciliabili. Ma la nascita costante, con flussi e riflussi, delle lotte non conduce di per sé alla prospettiva socialista. Essa necessita di un partito d'avanguardia che partecipi a ogni lotta per tentare di ricondurla al suo logico sviluppo: la prospettiva della conquista rivoluzionaria del potere. Continua dunque a essere vero ciò che scriveva Trotsky diversi decenni fa: «Senza il partito, al di fuori del partito, aggirando il partito, con un surrogato del partito, la rivoluzione proletaria non può vincere».
Una tesi ricorrente è quella della «integrazione» degli operai nella società borghese; un'altra – più audace – sancisce addirittura la «scomparsa» della classe operaia; un'altra ancora descrive l'ineluttabile «riflusso» e «abbandono della lotta» da parte degli operai. Queste teorizzazioni si rincorrono, con poche varianti, da più di cento anni. Il primo a parlare di una mancata «polarizzazione» tra le due classi estreme (negando così un postulato dell'analisi marxiana) fu il revisionista Bernstein agli inizi del Novecento. In genere, queste idee riemergono e trovano fortuna in concomitanza con la deriva a destra dei partiti operai e con la loro integrazione nel mondo borghese e nei suoi governi.
Di là dalla loro maggiore o minore raffinatezza hanno come unico scopo quello di decretare (su pezzi di carta) la vittoria «definitiva» della borghesia e del suo sistema sociale: o per scomparsa immaginaria dell'antagonista (la classe operaia); o per la sua presunta incapacità di battersi contro le classi dominanti: di volta in volta per una questione di «frantumazione», «integrazione», «assimilazione», ecc.
Ma il primo nemico di queste teorizzazioni è la realtà concreta dei fatti. Il proletariato (inteso non solo come classe operaia industriale ma, marxianamente, come la massa di coloro che sono costretti a vendere la propria forza lavoro per un salario) è in costante crescita, in parallelo con la concentrazione progressiva del capitale (industriale e finanziario, strettamente intrecciati). I salariati aumentano non solo su scala internazionale (con l'apporto di nazioni popolose che si industrializzano) ma crescono nei Paesi imperialisti: con lo stesso sviluppo del Terziario (che impiega − come salariati − milioni di lavoratori nei Trasporti e nelle Comunicazioni, che sono peraltro parte integrante della produzione industriale); con la proletarizzazione dei ceti medi nel Commercio (la grande distribuzione che assorbe il piccolo negoziante); e persino nell'Agricoltura (in cui scompare la piccola coltivazione a vantaggio delle grandi aziende).
Alla crescita oggettiva del proletariato corrisponde anche uno sviluppo (con ritmi differenti tra i diversi Paesi e con fasi alterne in ciascuno) delle sue lotte contro la borghesia. Ciclicamente la classe operaia si mobilita. Ciò accade perché la lotta di classe è inevitabile in una società divisa in classi in cui chi domina ha necessità di sfruttare e chi è dominato deve reagire per difendersi. Così come il movimento del diaframma nella respirazione non può essere fermato indefinitamente dalla semplice volontà, così la volontà dei «teorici» non può impedire il movimento della classe operaia. E ciò è tanto più vero in fasi di crisi economica del capitalismo, che creano le condizioni per un’ascesa delle lotte dei lavoratori in risposta al tentativo della borghesia di far loro pagare la crisi del suo sistema.
Ma le lotte e i movimenti non sono di per sé sufficienti a rovesciare il sistema sociale esistente. Per guadagnare successi immediati, anche parziali, per crescere su scala nazionale e sovrannazionale, ogni lotta, ogni sciopero, ha bisogno di collegamenti, di organizzazione, di una teoria generale e della memoria delle lotte precedenti. Tutto ciò può essere assicurato solo da un partito che intervenga nelle lotte con un programma rivoluzionario, cioè basato sugli obiettivi transitori. Il partito e il movimento sono necessari l'uno all'altro come spiega questa efficace immagine di Trotsky: «Senza un'organizzazione dirigente, l'energia delle masse si volatilizzerebbe come il vapore non racchiuso in un cilindro a pistone. Eppure il movimento dipende dal vapore e non dal cilindro o dal pistone» (dalla Prefazione del 1930 alla Storia della rivoluzione russa).
In alcuni casi, in assenza di un partito (o di sua egemonia sul movimento) si possono determinare crescite persino rivoluzionarie. Ma nessuna rivoluzione socialista è possibile in assenza di una direzione socialista che porti al movimento la coscienza socialista. Il socialismo e la lotta di classe nascono, infatti, l'uno accanto all'altra, non l'uno dall'altra. In questo senso, come argomenta Lenin nel Che fare?, «la coscienza socialista è qualcosa di portato nella lotta di classe dall'esterno [del rapporto produttivo padrone-operaio] e non qualcosa che ne sorge spontaneamente». Ciò perché nel suo sviluppo «spontaneo» la classe operaia tende a subordinarsi all'ideologia dominante (quella che asserisce la «naturalità» di un sistema di produzione in cui una minuscola minoranza di uomini sfrutta la stragrande maggioranza dell'umanità, detenendo il controllo dei mezzi di produzione).
Il processo di crescita della coscienza di classe avviene in modo discontinuo e contraddittorio. Discontinuo perché le lotte (in cui può incrinarsi, nell'esperienza materiale, la coscienza dominante, a condizione che ci sia il partito) non sono continue ma conoscono momenti di ascesa e di riflusso; contraddittorio perché il proletariato non è omogeneo ma è costituito da una serie di fasce concentriche di numero crescente e di consapevolezza decrescente. Se lo strato più avanzato è organizzato da un partito può guadagnare nel corso delle lotte al programma rivoluzionario anche strati più arretrati e rompere parzialmente l’altrimenti incontrastato dominio ideologico della borghesia (basato sul suo dominio materiale).
Solo un partito può condurre la classe operaia ad essere «classe per sé», cioè cosciente del proprio ruolo di classe potenzialmente dominante, cioè alla coscienza socialista, coagulando attorno a sé le classi subalterni e gli altri settori oppressi. Questo partito non può che essere minoritario nelle fasi ordinarie (laddove saranno maggioritari i partiti riformisti). Ma non per questo deve attendere un'inesistente «ora X» per costruirsi: anzi, potrà svilupparsi con ritmi velocissimi in una fase di ascesa della lotta solo a condizione di arrivarvi preparato avendo lavorato a organizzare la «fascia» più ristretta, quella più avanzata, quella costituita dall'avanguardia (cioè da quei lavoratori che in una determinata fase trascinano la lotta).
Questo partito di tipo particolare – il partito d'avanguardia – che fu teorizzato e costruito dai bolscevichi e grazie al quale essi vinsero nell'Ottobre 1917 è il partito che noi siamo impegnati a costruire. Un partito che intende costruirsi, nelle lotte e nelle rivendicazioni di tutti i lavoratori e di tutti gli oppressi; per questo la nostra azione nei confronti dei lavoratori non può limitarsi al semplice appoggio frammentario di singoli conflitti, ma deve andare oltre, nella direzione di una ricomposizione di tutte le rivendicazioni degli sfruttati e degli oppressi che abbia come motore, come leva centrale, la classe operaia stessa.
Per farlo, è necessario costruire un partito non solo programmaticamente ma anche organizzativamente operaio: anche se nella prima fase di costruzione è possibile che il corpo militante del partito non sia a maggioranza operaia: la natura di classe di un partito si determina anzitutto dal programma, che a sua volta influisce dialetticamente sullo sviluppo della sua composizione. Una corretta linea politico-organizzativa deve comunque andare in direzione di una forza operaia, secondo due direttrici generali: il baricentro dell’azione del partito e il suo programma.
Il baricentro dell’azione, tra gli operai e per la formazione di un numero sempre maggiore di quadri operai del partito (ovviamente senza tralasciare ogni altra lotta che attraversi la società e rifuggendo ogni ripiegamento operaista in senso deteriore e settario); e il programma, perché è a partire dalla partecipazione alla lotta, sotto una direzione conseguente, che si può sviluppare negli operai la coscienza socialista. Dunque il compito principale consiste nel massimizzare il nostro radicamento nella classe, sviluppando in essa un’azione concentrata di propaganda, agitazione e lotta, finalizzata alla costruzione di un partito operaio d’avanguardia.
Il partito d'avanguardia è un partito di quadri: ciò è il presupposto indispensabile perché esso possa trasformare in avanguardia settori più larghi dei lavoratori. I criteri di iscrizione e più in generale i principi politico-organizzativi su cui vogliamo costruire il nuovo partito sono gli stessi su cui si è basato il marxismo rivoluzionario dei bolscevichi, dell'Internazionale Comunista dei primi anni e della Quarta Internazionale prima della sua disgregazione. Dunque un partito di militanti, basato sul centralismo democratico, cioè su un insieme di norme di funzionamento che, garantendo l'elaborazione collettiva, il principio di maggioranza e i diritti delle minoranze, consenta la massima efficacia del partito.
A ogni programma corrisponde un partito. Il partito che vuole rovesciare il capitalismo è diverso da tutti gli altri, è un partito d'avanguardia. Un partito che è contemporaneamente integrato e separato (cioè distinto) dalla classe, si propone di dirigerne la parte più avanzata e in prospettiva di influenzarne settori di massa: è dunque un partito di quadri. Perché questa è la condizione necessaria – lo sosteneva Lenin, lo ha confermato tutta la storia successiva − per essere in grado «di elevare strati sempre più ampi al livello dell’avanguardia». Un partito, cioè, che non iscrive ogni manifestante e non è composto da una massa amorfa di iscritti: seleziona e forma quadri dirigenti delle lotte.
L'adesione al partito risponde ai criteri già indicati dai bolscevichi nello scontro cruciale del 1903 che li contrappose alla concezione organizzativa (e quindi politica, come si capirà meglio quando nel 1917 i menscevichi si schiereranno col governo liberale borghese) dei menscevichi. Ovviamente noi non siamo oggi paragonabili a un partito come quello bolscevico, nemmeno nei suoi primi anni di vita. Ma, a differenza dei centristi (che relegano il Che fare? alla «specificità russa»), noi non relativizziamo i concetti politico-organizzativi del bolscevismo – che difatti erano intesi come universali, tanto da costituire l’architrave delle tesi dei primi congressi dell’Internazionale e di tutte le sue sezioni nazionali. Se le tappe di costruzione di un partito sono differenti a seconda della sua taglia, i principi generali non mutano.
I criteri per l'adesione al partito sono: la condivisione del programma generale, la militanza regolare, il pagamento delle quote per il finanziamento del partito, l'accettazione della disciplina e cioè del centralismo democratico. La distinzione tra militanti e simpatizzanti (cioè coloro che manifestano una condivisione generale ma non sono disponibili a sottostare ai criteri qui elencati) deve essere chiara. Solo con la militanza si acquisisce il diritto di definire la linea e le strutture del partito. È questa peraltro l'unica forma non solo efficace ma anche effettivamente democratica, che rifugge dalla finta «apertura» dei partiti di massa, in cui chiunque, purché iscritto, ha diritti decisionali anche se non partecipa alla militanza, alla discussione e alla costruzione quotidiana del partito (finendo così abitualmente per sostenere acriticamente il leader di turno).
L'adesione è una scelta individuale ma anche il partito ha il diritto di valutare l'effettiva condivisione di chi vuole entrare nelle sue file. Per garantire questa possibilità, ogni nuovo militante è per una fase iniziale (di sei mesi) «candidato»; ha cioè gli stessi doveri degli altri militanti, ma non gode di diritti elettorali e ha solo voto consultivo. Al termine di questa fase, sarà la sua struttura di base a votare sull'accettazione come militante effettivo.
Il principio politico-organizzativo che informa il partito che noi vogliamo costruire è il centralismo democratico. Non la sua caricatura stalinista, ma la modalità attuata dal partito bolscevico e dalle sezioni dell'Internazionale Comunista nei primi anni, così come dalle sezioni della Quarta Internazionale prima della sua disintegrazione negli anni Cinquanta.
Il centralismo democratico non è una norma giuridica astratta ma una modalità per garantire l'attuazione degli scopi rivoluzionari del partito. Esso prevede una forte centralizzazione e una disciplina senza le quali il partito non potrebbe porsi il compito storico di dirigere le masse contro la vecchia società borghese.
Il centralismo democratico prevede la massima discussione interna, intesa non come un esercizio per l'affermazione individuale, ma come passaggio per l'assunzione di scelte corrispondenti alle necessità del partito, frutto di un'elaborazione realmente collettiva, che coinvolga l'intero corpo militante e che non siano assunte in solitudine da qualche leader più o meno illuminato.
Perché la discussione sia però realmente funzionale a un partito concepito come organizzazione di lotta, essa deve essere regolamentata dal principio di maggioranza, che implica la piena e leale disciplina di ciascuno e di eventuali minoranze nel momento dell'attuazione della linea discussa, così che il partito si presenti all'esterno in modo uniforme, con una completa unità nell'azione. Perché la disciplina sia reale e frutto di convinzione è necessario che il partito garantisca sia durante la fase di elaborazione di una scelta che successivamente – fermo restando l'applicazione unitaria – la possibilità di ogni minoranza di diventare maggioranza. Ciò implica il riconoscimento del diritto di costituire tendenze (quando il disaccordo è su singole questioni) e frazioni interne (quando il disaccordo è su aspetti generali) per sostenere in modo organizzato, con altri militanti, una battaglia politica tesa a modificare gli orientamenti del partito.
Divergenze di vedute e, se necessario, tendenze e frazioni interne fanno parte della fisiologica attività di un partito vivo. Altra cosa è la frazione pubblica (cioè con esplicitazione all'esterno del partito di posizioni diverse da quelle assunte a maggioranza): essa può essere consentita dal partito solo in casi estremi (come ultimo tentativo per mantenere un quadro unitario) ma non costituisce un diritto in ogni fase, bensì l'eccezione alla norma. Anche in questi casi, tuttavia, ogni militante del partito si disciplina sempre nell'azione alla linea definita a maggioranza.
3) Il trotskismo come marxismo odierno
Gli assi fondamentali del nostro partito sono quelli del marxismo rivoluzionario: un lungo filo rosso che a partire dalla Lega dei comunisti di Marx ed Engels si sviluppa nella costruzione del partito bolscevico di Lenin e nella Rivoluzione d’ottobre; quindi nella costruzione della Terza Internazionale di Lenin e di Trotsky, come partito della rivoluzione mondiale; infine nella lotta di Lenin fino al 1924 e dell’Opposizione di sinistra animata da Trotsky contro la degenerazione burocratica stalinista, fino alla fondazione della Quarta Internazionale.
La lotta per la costruzione del partito rivoluzionario nel nostro Paese ha una lunga e travagliata storia, una storia che affonda le proprie radici nella storia del marxismo rivoluzionario mondiale. Il movimento comunista fin dalle origini esprime una vocazione internazionalista. Marx ed Engels, infatti, intesero costruire la Lega dei comunisti (1847-1852) come partito rivoluzionario mondiale, il cui testo programmatico, il Manifesto del Partito comunista del 1848, dopo oltre centocinquanta anni conserva la sua attualità. I contributi teorici e politici di Marx ed Engels si svilupparono nel corso della seconda metà del XIX secolo: nell’ambito della battaglia politica nella Prima Internazionale; nell’approfondimento dell’analisi del modo di produzione capitalistico e della critica dell’economia politica; nella analisi dell’origine e della natura dello Stato; nella acquisizione degli insegnamenti emersi nella prima rivoluzione proletaria, la Comune di Parigi, quali la necessità della distruzione dell’apparato statale borghese e l’edificazione di un nuovo potere statale operaio basato sulla dittatura del proletariato per l’emancipazione del lavoro. In questi contributi ed analisi, qui schematicamente indicati, diedero un contenuto materiale all’analisi dialettica e alla costruzione di partiti rivoluzionari.
Lenin contribuirà in modo determinante allo sviluppo del marxismo liberandolo dal revisionismo riformista dominante nella Seconda Internazionale, coniugando la lotta per la costruzione del partito rivoluzionario, su solide basi programmatiche e organizzative, all’approfondimento dell’analisi dell’imperialismo e della guerra. La lezione leninista sta nel fatto che il partito non rappresenta un fine in sé, bensì uno strumento. E, come tale, ad esso corrisponde un programma. Dunque, un partito è un programma, il programma per la rivoluzione. La Terza Internazionale delle origini, i cui primi quattro congressi condensano l’esperienza storica fino ad allora accumulata, proprio in quanto partito mondiale della rivoluzione socialista, doveva assicurare la direzione della rivoluzione mondiale, perché il socialismo si costruisce sul terreno internazionale. La sua ultima battaglia Lenin la dedicò a salvaguardare lo Stato operaio nato dalla rivoluzione contro i primi segni della degenerazione burocratica, quando iniziava a delinearsi una casta parassitaria che proprio per difendere i propri privilegi si contrapponeva socialmente alla classe operaia e politicamente al programma del marxismo rivoluzionario, che cominciava ad avere in Stalin il proprio massimo rappresentante. Una battaglia portata avanti da Trotsky e dall’Opposizione di sinistra.
Il contributo di Trotsky al marxismo rivoluzionario è stato vitale per il successivo sviluppo sulle proprie basi: dall’analisi del fascismo alla teoria della Rivoluzione permanente; dalla lotta contro il settarismo del terzo periodo («socialfascismo») alla lotta contro i fronti popolari (di collaborazione con la «borghesia democratica» nei Paesi imperialisti e subordinazione alle borghesie nazionali nei Paesi dipendenti) di una Terza Internazionale ormai definitivamente stalinizzata ed in via di scioglimento; dalla necessità della rivoluzione politica negli Stati operai degenerati, proprio per aprire la strada verso il socialismo ed impedire la restaurazione capitalista da parte della burocrazia stalinista «divenuta l’organo della borghesia mondiale nello Stato operaio», alla fondazione nel 1938 della Quarta Internazionale, come partito mondiale della rivoluzione socialista. Il cui testo programmatico, L’agonia del capitalismo e i compiti della Quarta Internazionale, più noto come Programma di transizione, sintetizza le acquisizioni teoriche e le esperienze, sul terreno della lotta di classe internazionale, nella fase successiva alla vittoria della Rivoluzione d’ottobre: un testo che ancora oggi mantiene tutta la sua attualità.
In questo senso, il partito che vogliamo è un partito trotskista, poiché il trotskismo ha rappresentato e rappresenta la reale continuazione del bolscevismo e della Rivoluzione d’Ottobre; anzi, l’unico ed autentico sviluppo del marxismo rivoluzionario sulle fondamenta politico-programmatiche del leninismo. Un partito impegnato a guadagnare la maggioranza politicamente attiva dei lavoratori ad un progetto di trasformazione rivoluzionaria della società attraverso il radicamento nei luoghi di lavoro e la partecipazione alle lotte sulla base di un programma di rivendicazioni transitorie; un partito che non disdegna anche la presenza «strumentale» nelle istituzioni borghesi (allo scopo, cioè, di «utilizzarle» come tribuna per l’agitazione rivoluzionaria) per «mobilitare le masse sulle parole d’ordine della rivoluzione proletaria» e ben consapevole che «il parlamento non può essere in nessun caso (…) il teatro di una lotta per delle riforme e per il miglioramento delle condizioni della classe operaia» (Tesi sul parlamentarismo del II Congresso dell’Ic).
Il partito che noi vogliamo costruire combatte una battaglia di egemonia all’interno della classe operaia contro il riformismo e il centrismo, agenti della borghesia all’interno della classe, entrambi assertori di una concezione che oltre a negare i principi fondamentali del marxismo rivoluzionario, tra cui la dittatura del proletariato, subordinano il proletariato alla borghesia e ai suoi governi ad ogni livello istituzionale.
Il crollo dello stalinismo e la crisi della socialdemocrazia, da un lato; dall’altro, la ripresa della lotta di classe e la resistenza dei popoli alle aggressioni coloniali ripropongono il programma della rivoluzione socialista internazionale che riconduca la produzione e le risorse naturali sotto il controllo cosciente delle masse lavoratrici. Solo un partito trotskista che fa proprio il patrimonio teorico e politico del marxismo rivoluzionario, il cui filo rosso è stato qui sommariamente descritto, può rappresentare una soluzione alla crisi di direzione del movimento operaio nel nostro Paese e sul terreno internazionale.
Perché serve l'Internazionale trotskista
Una delle grandi contraddizioni in cui viviamo è quella tra la nascita, negli ultimi due anni, di movimenti, lotte e rivoluzioni a livello internazionale, in ogni continente, e la contemporanea assenza di una Internazionale dei lavoratori, di un partito mondiale. Ciò è a sua volta l'esito della madre di tutte le contraddizioni, segnalata da Trotsky già settant'anni fa: quella tra la maturazione delle condizioni oggettive per porre fine al capitalismo e l'immaturità delle condizioni soggettive, cioè a dire della direzione rivoluzionaria che possa compiere questa opera gigantesca. A questo si riferiva Trotsky scrivendo, nel Programma di transizione, che «La crisi storica dell'umanità si riduce alla crisi della direzione rivoluzionaria».
Noi pensiamo che sia proprio questa contraddizione ad avere ostacolato fin qui lo sviluppo della lotta in diversi Paesi laddove la lotta contro le misure di austerità dei governi borghesi è ancora a livelli arretrati (come è il caso dell'Italia o della Germania); ad aver reso difficile lo sbocco rivoluzionario in altri Paesi dove invece la lotta è già molto avanzata (si pensi alla Grecia), e ad avere impedito fin qui la vittoria effettiva delle rivoluzioni già iniziate da oltre un anno e ancora in corso nei Paesi arabi e nel Medio Oriente.
Per questo ci pare utile provare a riassumere qui il perché a noi sembra indispensabile avanzare nella costruzione di una Internazionale rivoluzionaria e perché pensiamo che non possa che essere la Quarta Internazionale: un progetto in cui sono impegnate contemporaneamente le sezioni della Lega Internazionale dei Lavoratori (Lit-Quarta Internazionale) in decine di Paesi e nei diversi continenti, a partire dall'Europa.
La Lit non ha la pretesa di essere oggi la Quarta Internazionale. Lavora per la sua ricostruzione (dopo che varie crisi, seguite alla fondazione nel 1938, hanno di fatto distrutto l'organizzazione fondata da Trotsky: ma questo tema sarà oggetto di un futuro articolo).
Perché serve un'Internazionale rivoluzionaria? Proviamo intanto a rispondere a questa domanda con tre risposte, per poi vedere di capire chi si propone oggi questo compito, in Italia.
Primo: perché la lotta di classe è internazionale
Nella Rivoluzione permanente Trotsky scrive: « (...) il carattere internazionale della rivoluzione socialista è la conseguenza delle condizioni dell'economia e della struttura sociale dell'umanità. L'internazionalismo non è un principio astratto, bensì il riflesso politico e teorico del carattere internazionale dell'economia, dello sviluppo mondiale delle forze produttive e dell'estensione mondiale della lotta di classe».
In altre parole: il capitalismo è un sistema internazionale e certo il socialismo - cioè una società qualitativamente superiore al capitalismo - non potrà costruirsi su basi nazionali, più arretrate: al contrario, avrà necessità (come la stessa esperienza del crollo dell'Urss stalinista dimostra) di costruirsi su scala internazionale.
Ma non è un problema del domani: cioè non è cosa che si porrà dopo una rivoluzione vittoriosa. L'internazionalismo segna il percorso verso quella rivoluzione, è l'unica strada che la rende possibile.
Secondo: perché le lotte non bastano, serve il partito
Questo punto è il più importante ma è anche quello che svilupperemo più rapidamente. Vale infatti quanto abbiamo scritto varie volte in relazione al partito nazionale: senza partito rivoluzionario non c'è teoria rivoluzionaria né movimento rivoluzionario.
Per quanto riguarda i riflessi pratici, visibili a occhio nudo, basti pensare alla necessità evidente, urgente, imperiosa di unire tra loro le lotte che si stanno sviluppando nei diversi continenti e Paesi. Così come unire le lotte in uno stesso Paese, superando l'isolamento di ciascuna, spezzando il tentativo della borghesia di contrapporre i proletari di Paesi differenti (e di etnie o origini differenti, nativi e immigrati), consentendo invece di amplificarne la forza, l'unione internazionale. Il confronto (in primo luogo) e il coordinamento (in secondo luogo) tra le diverse esperienze, consentirebbe già oggi di fare dei giganteschi balzi in avanti, usando la forza delle situazioni più avanzate (le rivoluzioni nei Paesi arabi) per trainare le lotte in Europa; di far seguire alle punte della lotta in Europa (ad es. in Grecia) i Paesi dove la lotta ancora è più arretrata.
Senza un'Internazionale di questo tipo, invece, tutto il coraggio e gli sforzi delle masse in lotta, tutte le loro vittorie parziali (come sono state il rovesciamento di governi e regimi in Nord Africa), sono destinate alla sconfitta. Non solo: riformisti e stalinisti, oggi come ieri, oggi nella loro versione che è la caricatura in sedicesimo di quella di ieri, si muovono su basi nazionali e talvolta nazionaliste.
Terzo: perché l'Internazionale non nascerà come sommatoria di partiti
Alcuni teorizzano la formazione prima di partiti e solo in seguito di una Internazionale. Viceversa la costruzione di un'Internazionale e, contemporaneamente, delle sue sezioni, è l'unica garanzia di costruire gli stessi partiti su un programma realmente internazionalista (e quindi comunista), sottraendosi (per quanto è possibile) alle pressioni nazionali e borghesi. Quelle pressioni che portarono all'esplosione della Seconda Internazionale (il 4 agosto) e allo scioglimento per mano dello stalinismo della Terza Internazionale.
L'Internazionale e i partiti che la compongono possono essere costruiti solo in un processo combinato: non si tratta di erigere prima i muri nazionali e poi di porvi sopra l'Internazionale come se fosse il tetto della casa. La relazione tra la costruzione nazionale e internazionale è dialettica. Certo lo sviluppo dei partiti è fondamentale per lo sviluppo dell'internazionale; ma nessun partito può fare il salto fondamentale (arrivare a dirigere una rivoluzione e prendere il potere) senza l'aiuto, l'elaborazione, il sostegno, la partecipazione dell'Internazionale.
Lo stesso programma rivoluzionario può essere elaborato solo su scala internazionale. In un testo del 1928, Critica al Progetto di programma dell'Internazionale Comunista, Trotsky scrive: «Il partito rivoluzionario può basarsi solo su un programma internazionale (...). Il programma comunista internazionale non è mai la sommatoria dei programmi nazionali (...). Il programma internazionale deve fondarsi sull'analisi delle condizioni e tendenze dell'economia mondiale e del sistema politico nella loro totalità, tenendo in conto tutte le rispettive connessioni e contraddizioni, cioè l'interdipendenza reciprocamente antagonista dei suoi differenti elementi. Nell'epoca attuale, ancora più che in passato, l'orientamento nazionale del proletariato deve e può trovare origine solo in un orientamento mondiale, e non all'inverso. Questa è la differenza principale e basilare tra l'internazionalismo comunista e tutte le varianti di socialismo nazionale».
Non un'internazionale qualsiasi: la Quarta
Quale altra forza del movimento operaio, ad eccezione dei trotskisti, ha combattuto una battaglia al contempo contro la borghesia (tanto quella «democratica» come contro quella fascista) e contro gli agenti della borghesia nel movimento operaio (riformisti e stalinisti)? Quale altra corrente del movimento operaio ha difeso e sviluppato sulle sue basi il marxismo, senza diventare una setta sterile (come è diventato quanto rimane del bordighismo), a parte il trotskismo? Nessuna. Solo i trotskisti conseguenti rivendicano quello che in fondo è solo l'abc del comunismo da Marx in poi: la costruzione di un partito d'avanguardia, l'indipendenza dalla borghesia e dai suoi governi, per guadagnare nel vivo delle lotte le masse al rovesciamento rivoluzionario del capitalismo e all'instaurazione del potere dei lavoratori, cioè alla dittatura del proletariato, primo passo verso il socialismo e la scomparsa definitiva della divisione in classi della società.
Questo spiega perché secondo noi dire «trotskismo» oggi equivale a dire marxismo. Il trotskismo è il marxismo dei giorni nostri. E siccome l'Internazionale che serve e che vogliamo e stiamo formando si deve basare sul marxismo e non certo su qualche sua variante riformista, questa Internazionale non potrà che essere la Quarta, laddove il numero, come spiegava Trotsky, indica un programma, una prospettiva.