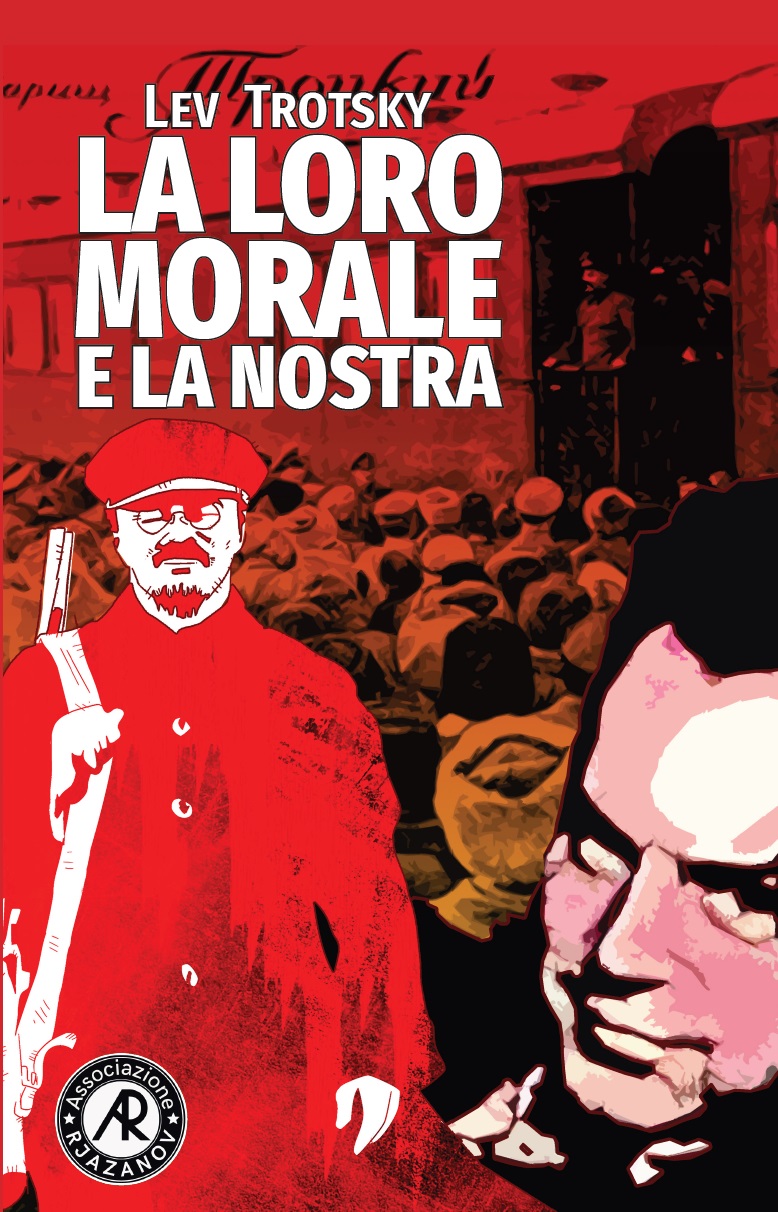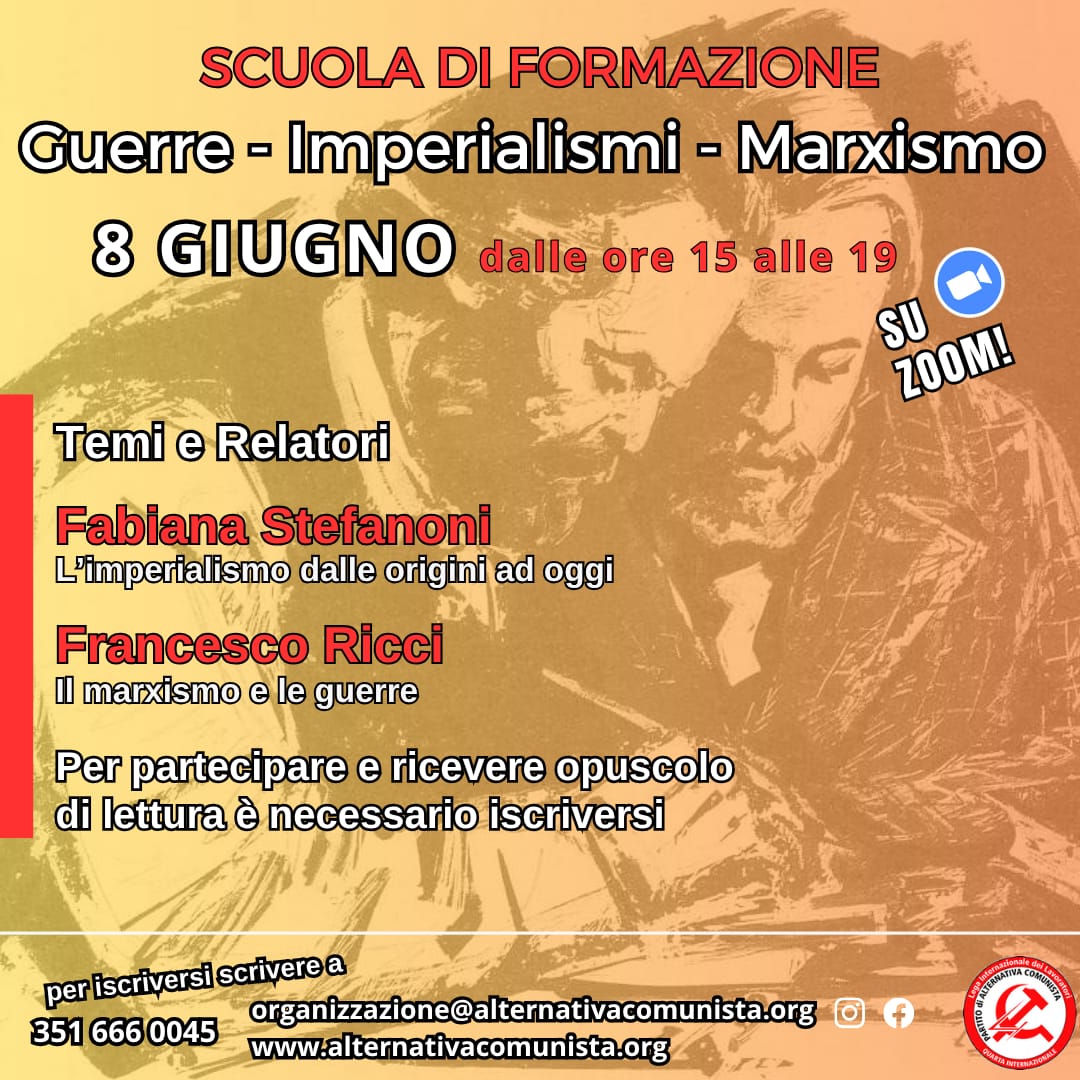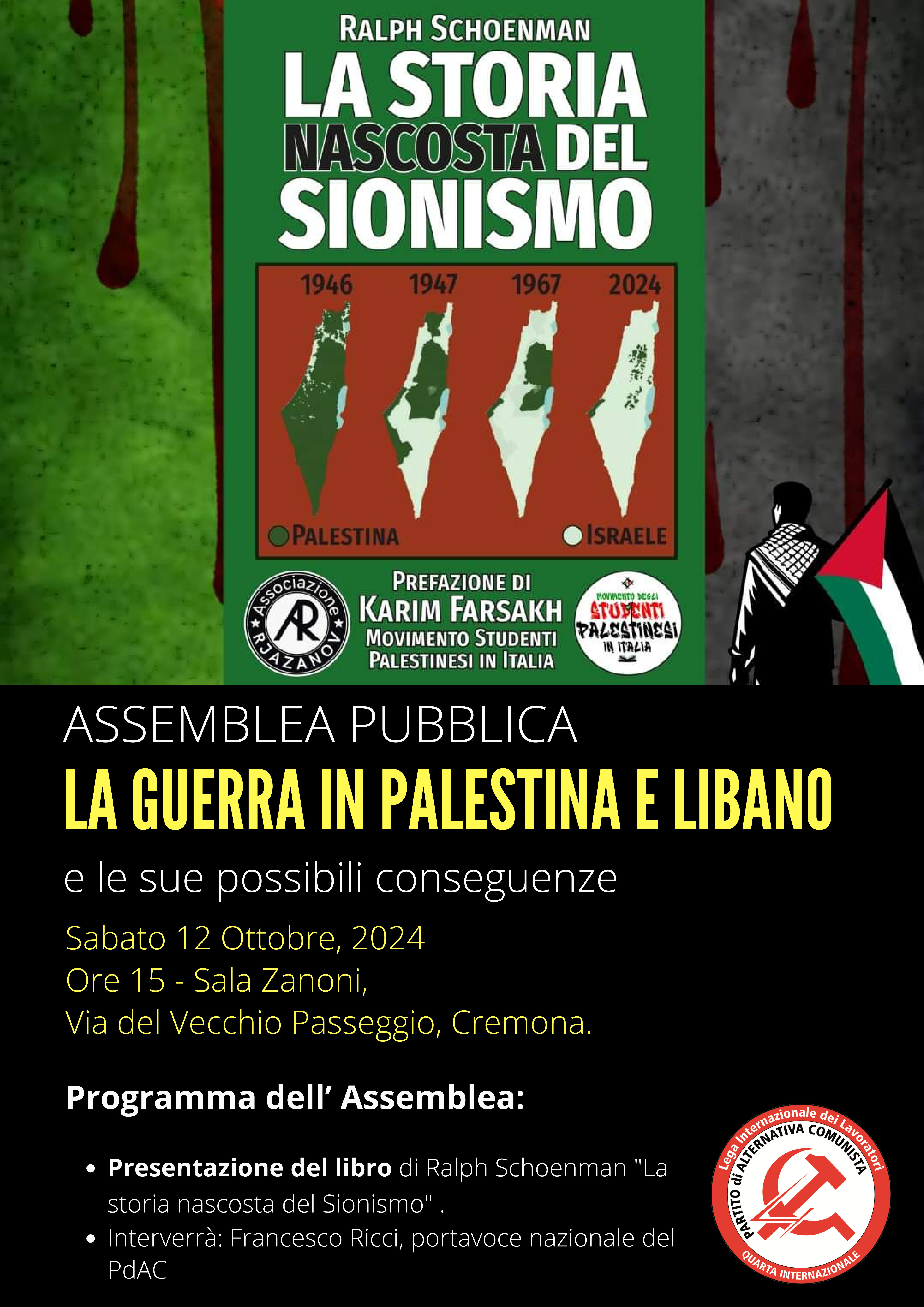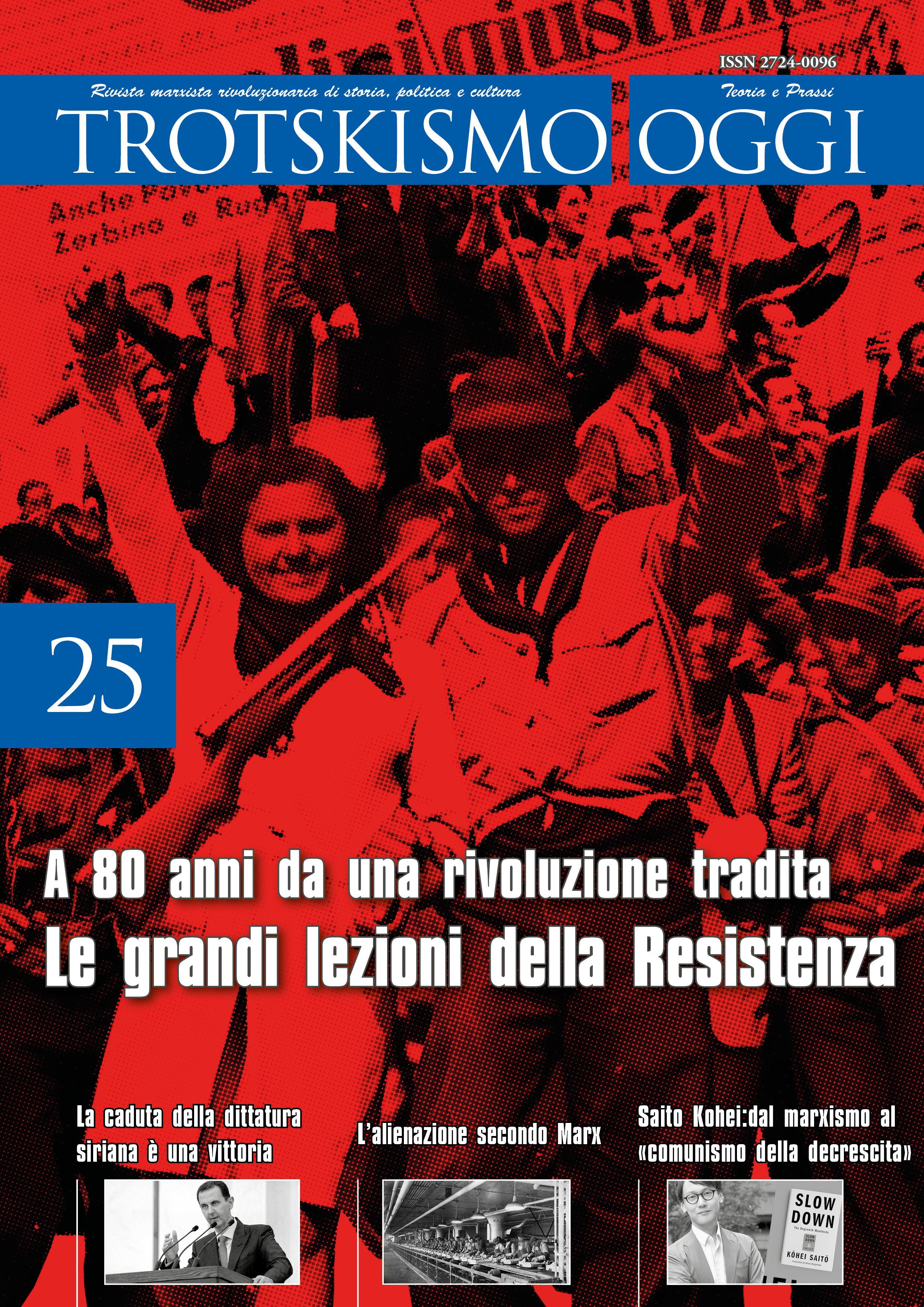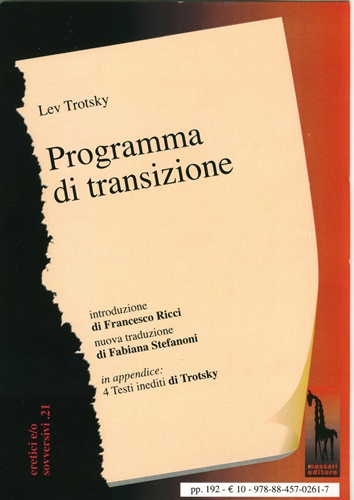CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE DONNE DEL PDAC
VII CONGRESSO
LA LOTTA CONTRO L’OPPRESSIONE DELLE DONNE
La situazione mondiale oggi
La crisi economica in cui il capitalismo si trova dal 2007 – aggravata dalla pandemia – ha ben illuminato sul modo in cui questo sistema sgrava l'onere del proprio mantenimento sugli strati più oppressi e sfruttati della società ed ha infranto l'idea diffusa che le conquiste economiche e politiche ottenute con le lotte sotto il regime democratico borghese siano permanenti, in quanto soggette alle esigenze del capitale e ai cambiamenti nei rapporti di forza tra classi e settori di classe.
Il contrasto tra la vita reale e la vita «ideale» sotto il capitalismo è diventato palese, confermando così che il raggiungimento dell'uguaglianza davanti alla legge non è sinonimo del raggiungimento dell'uguaglianza nella vita reale. Per quanto riguarda la condizione femminile, questo contrasto emerge in modo brutale dalle statistiche che riempiono le pagine dei media borghesi: il 70% degli analfabeti sono donne e bambine perché a loro è impedito l’accesso all’istruzione; i tagli alla spesa sociale con la conseguente riduzione di servizi pubblici e gratuiti e la facilità di fuoriuscita dal mercato del lavoro hanno spinto le donne sempre più tra le mura domestiche a sopperire con il loro lavoro di cura alle mancanze dello Stato; nonostante gli enormi progressi scientifici e tecnologici, ogni anno 500mila donne in tutto il mondo muoiono per complicazioni in gravidanza o durante il parto; gli attacchi al diritto all’aborto e alla contraccezione negano alle donne una reale possibilità di autodeterminarsi dal punto di vista sessuale e riproduttivo, causando circa 500 vittime ogni giorno per le conseguenze di aborti illegali clandestini. Allo stesso tempo, il corpo delle donne viene mercificato relegandole nel ruolo di oggetto sessuale: in questa società degenerata moralmente, diventa una merce da vendere e da comprare.
È quindi purtroppo facile capire da dove si origina quella che persino l’Onu ha definito una vera e propria pandemia, cioè la violenza fisica (spesso mortale) che sta colpendo l’universo femminile: stupri, aggressioni, mutilazioni, molestie, matrimoni forzati, violenze di ogni tipo commesse sia nella sfera privata che in quella pubblica, da conoscenti ed estranei, e nelle circostanze e nei contesti più svariati. Nessuna donna è al sicuro. Secondo i dati dell’Onu, 1 donna su 3 ha subito o subirà una qualche forma di violenza nel corso della sua vita. La violenza inizia presto: la metà delle donne dell'Unione europea ha denunciato molestie sessuali già a 15 anni. L’aspetto più drammatico di questa violenza è il femminicidio: ogni 11 minuti una donna viene uccisa in qualche parte del mondo semplicemente perché è una donna. Per non parlare degli stupri correttivi commessi nei confronti di persone lgbt+ e dei transfemminicidi, le cui vittime sono quasi sempre donne trans.
In questo scenario, le donne sono alla mercé di ogni forma di sopruso, dal paternalismo alla discriminazione, dalla molestia all’abuso fisico. Il capitalismo ha costruito e fomentato questo scenario, sfruttando la disuguaglianza tra uomo e donna a proprio vantaggio, acutizzandola in alcuni periodi storici, come quello attuale: mentre emana leggi che dovrebbero proteggere le donne, diffonde contemporaneamente «buoni consigli» sul non uscire di casa, di sera, sull’abbigliamento, ecc. che hanno l’unico scopo di abituare le donne a convivere con la violenza, perché si rassegnino al fatto che potrebbero essere le prossime a sparire o a essere assassinate, perché si chiudano in casa ad aspettare tempi migliori. Il sistema capitalista utilizza l’ideologia maschilista per sfruttare, opprimere e discriminare in generale i più deboli della società, in questo caso le donne.
L’ondata di violenza che ha investito l’universo femminile mondiale non è frutto di un’emergenza, ma la conseguenza di scelte precise, operate da un sistema in crisi, quello capitalistico, che cerca di auto conservarsi. L'esacerbazione della violenza e dell'oppressione è, insieme all'aumento dello sfruttamento dei lavoratori, una tendenza del capitalismo.
L'ascesa di governi e movimenti di estrema destra non è una semplice coincidenza, ma l'espressione di queste dinamiche. Le misure adottate da questi governi che si basano sulla difesa della famiglia eterosessuale tradizionale, con conseguenti attacchi al diritto all'aborto e ai diritti delle persone trans, e sullo smantellamento dello Stato sociale, hanno avuto un impatto diretto sulla vita delle donne. Il tentativo è quello di individuare dei capri espiatori per distogliere l'attenzione dai veri colpevoli per le condizioni di vita di proletarie e proletari, ma, soprattutto, per dividerci come classe, in modo da poter attuare più facilmente le misure che vogliono imporre.
Ma non possiamo dimenticare l’operato dei governi cosiddetti progressisti che difendono la classe operaia solo a parole, senza attuare politiche concrete. Con la retorica del cambiamento e dell'inclusione, attuano piani di tagli indiscriminati ai servizi, annullano le conquiste sociali e peggiorano le condizioni di vita dei più vulnerabili, difendono gli interessi delle aziende e finiscono per mantenere le politiche di austerità già in atto da anni. Questi governi, alleati con le burocrazie sindacali e i dirigenti traditori dei movimenti sociali, demoralizzano la classe operaia impedendone la mobilitazione indipendente, aprendo così la strada all'estrema destra che si presenta come una falsa alternativa.
I movimenti «femministi»
Da diversi anni ormai il movimento di liberazione delle donne vede una partecipazione massiccia e attiva, segnale della necessità, avvertita soprattutto dalle giovani generazioni, di trovare risposte e soluzioni ad una condizione, quella delle donne, che non accenna a migliorare. Al dato quantitativo, sicuramente importante, se ne unisce uno qualitativo: finalmente il dibattito sulla condizione delle donne è uscito dai circoli di intellettuali e dalle accademie per ritornare ad essere «di massa» e per riappropriarsi di spazi di contestazione e di protesta pubblici, recuperando così parte della tradizione di lotta che ha caratterizzato il movimento di liberazione delle donne negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso.
A livello di direzioni politiche, nei movimenti per la liberazione delle donne, ad oggi si confrontano essenzialmente due posizioni che potremmo sintetizzare in base alle soluzioni che propongono: una, più liberale, che fa riferimento al piano delle riforme e dell’uguaglianza garantita per legge; un’altra, più radicale, che spinge per un cambiamento sociale e culturale sia a livello di singoli individui sia a livello di collettività. Due posizioni che spesso nel dibattito si intrecciano indicando l’una nell’altra il naturale completamento, in particolare quando si afferma che non è sufficiente una legge per sradicare la visione della donna e del suo ruolo nella società, se non è accompagnata da un lavoro educativo all’affettività fin dall’infanzia, che formi nuove generazioni pronte a rimuovere gli ostacoli della disuguaglianza.
Entrambe le posizioni, da sole o in combinazione, hanno il difetto di prescindere da un’analisi più profonda del quadro generale della condizione delle donne, analisi che permetta non solo di delineare la cornice ma anche di comprendere le reali responsabilità per cercare soluzioni conseguenti ed efficaci. Le attuali direzioni del movimento femminista, anche quelle che appaiono più radicali, hanno abbandonato ogni prospettiva anti-sistemica, naturalizzando il dominio del capitale e proponendo la via della micro-resistenza individuale per cercare di potenziare le democrazie liberali. Infatti, anche quando vengono denunciate le responsabilità del capitalismo, si adotta il metodo della critica culturale, annullando la materialità del sistema e ponendosi su una linea completamente riformista. O, quando si denuncia la struttura patriarcale della società con il suo portato di violenza sessista, ci si pone in un’ottica di educazione e di evoluzione culturale.
L’oppressione della donna nella società borghese è un’oppressione che riguarda tutte le donne, sia borghesi che proletarie, ma come marxisti rivendichiamo una «separazione netta» con le donne della grande borghesia.
A differenza delle donne borghesi, la donna proletaria non sfrutta altri né si dedica all’affermazione di una sua specifica attività economica, ma, costretta a dare il meglio delle sue forze e la maggior parte del suo tempo al capitalista che la sfrutta, deve arrabattarsi in qualche modo per ottemperare ai bisogni della casa e dei figli, bisogni che il sistema capitalistico fa ricadere sulle sue spalle; la famiglia, in quanto unità economica della società borghese, fa emergere una contraddizione che pone storicamente il problema di una emancipazione generale non solo dall’oppressione domestica, ma da tutta la società capitalistica, che opprime le donne sia fra le mura di casa che nei posti di lavoro e nella vita sociale.
Le donne proletarie, nelle fabbriche e nei posti di lavoro, vivendo le condizioni di sfruttamento che vivono i proletari maschi, subiscono inevitabilmente anche l’influenza della lotta di resistenza quotidiana che i proletari conducono contro i capitalisti e possono appropriarsi pian piano dei mezzi e dei metodi della lotta proletaria. La lotta delle donne proletarie, proprio per la loro condizione materiale di lavoratrici salariate, «non può essere una lotta simile a quella che conduce la donna borghese contro l’uomo della sua classe; al contrario, la sua è la lotta insieme all’uomo della sua classe contro la classe dei capitalisti» (Zetkin); classe quest’ultima che è formata da uomini e donne della borghesia e che ha tutto l’interesse a difendere il modo di produzione capitalistico e la società eretta su di esso, ossia un modo di produzione basato sullo sfruttamento del lavoro salariato grazie al quale mantiene soggetta la grande maggioranza della popolazione costituita dalla massa dei lavoratori da cui estorce il plusvalore.
L’importanza della lotta di classe
Per i marxisti non vi sono soluzioni storiche specificamente femminili al problema della donna nella società borghese. Però un’organizzazione che si dichiari marxista e rivoluzionaria non può che abbracciare la causa della lotta per l’emancipazione femminile come parte integrante e centrale di una lotta per una società nuova.
La soluzione all’oppressione della donna non sta in particolari ricette giuridiche (eguaglianza per legge tra maschi e femmine, partecipazione democratica alla vita politica ecc.) come pretendono tutti i partiti e i movimenti democratico-borghesi: i mezzi giuridici non rivoluzionano nulla, ma si limitano a istituzionalizzare quello che per una data società è già diventato un fatto o un’esigenza. Né può essere il risultato di una particolare educazione della donna, e dei maschi, o di soluzioni individuali.
Per i marxisti i diritti si conquistano sul campo, nella trincea della lotta di classe e non certo attraverso percorsi istituzionali che si rivolgono a quelle stesse forze politiche che da anni sottraggono risorse vive alle donne in difficoltà: l’oppressione della donna finirà quando crolleranno le basi materiali su cui poggia, ovvero il sistema capitalista.
Ciò non toglie che le rivendicazioni di parità salariale, eguaglianza giuridica, eliminazione di ogni discriminazione fra i sessi ecc., e rivendicazioni più specifiche che riguardano le condizioni di esistenza delle donne facciano parte degli obiettivi immediati della lotta classista del proletariato: dobbiamo essere e siamo in prima fila nella lotta contro la doppia oppressione delle donne nel capitalismo. Nel nostro programma calibrato in un'ottica transitoria, rimangono centrali le rivendicazioni di un pieno impiego contro ogni flessibilità e precarizzazione, di salari uguali per uguali mansioni, del controllo delle lavoratrici sui tempi e sugli orari di lavoro, nonché sul «rischio zero» negli ambienti di lavoro, di un'istruzione di massa e pubblica senza discriminazioni di classe e secondo le vere inclinazioni di ognuna; la battaglia per il mantenimento e il potenziamento dei servizi pubblici a supporto delle donne, come asili nido, lavanderie e mense sociali di quartiere, centri per anziani e disabili, consultori e ambulatori pubblici diffusi nel territorio, per sottrarle al doppio lavoro forzato di cura e liberare il tempo per le attività politiche, sindacali, culturali; il contrasto alle politiche familistiche portate avanti dai governi borghesi di vario segno; la lotta per il diritto ad una procreazione e ad una sessualità libere e responsabili.
Si tratta per l’appunto di obiettivi della lotta di classe del proletariato, cioè di una lotta che non si ferma all’involucro giuridico della società borghese, ma punta molto più in alto, alla distruzione dell’intero sistema economico, sociale e politico capitalistico. Non esiste un prima e un dopo: affrontiamo la contraddizione di genere contestualmente al conflitto di classe perché è proprio nel quadro dello sviluppo della lotta di classe che le istanze delle donne lavoratrici riescono a produrre enormi passi in avanti, non solo per le donne, ma per tutti.
Per i marxisti la battaglia per la liberazione della donna non può essere condotta isolatamente, ma deve essere portata avanti dalla classe lavoratrice nel suo insieme, in una lotta generale contro il sistema.
Il punto di vista di classe è l’unico che, promuovendo un cambiamento generale della società, può minare alla base le radici stesse dell’oppressione femminile, come di ogni altra forma particolare di oppressione.
Il fine del marxismo è costruire una società giusta, nella quale non esista spazio per alcuna forma di sfruttamento, nella quale gli individui possano esprimere la propria individualità in piena libertà e senza le costrizioni imposte da una morale bigotta.
Il marxismo si pone obiettivi ambiziosi e per poterli realizzare necessita di tutta la forza della classe lavoratrice unita. L’unità della classe lavoratrice nella lotta, sulla base di un programma rivoluzionario, è la sola arma che potrà renderci liberi dal giogo del capitale.
La Commissione Lavoro Donne del Pdac cui è demandato il coordinamento di questo lavoro tra le proletarie, ha negli ultimi anni consolidato un percorso di formazione interna a sé e nel partito, producendo e pubblicando articoli per il sito, per il giornale e per la rivista, oggetto di discussione e strumento di diffusione della concezione che muove il nostro lavoro; ha individuato parole d’ordine concrete da portare nella lotta di classe quali obiettivi transitori. Le date storiche dell’8 marzo, del 28 settembre e del 25 novembre, per noi non sono mere scadenze da calendario, ma importanti ricorrenze nella lotta per l’emancipazione femminile, rispettate con dichiarazioni, volantini, partecipazione a manifestazioni, iniziative pubbliche.
È nostro compito nel prossimo futuro continuare a promuovere e sostenere le lotte che mirano a migliorare le condizioni di vita delle donne sfruttate e oppresse in questo sistema e creare un’unità d’azione con la classe lavoratrice. La partecipazione ai movimenti e il sostegno attivo alle donne impegnate nelle lotte di Resistenza nazionale contro l’oppressione imperialista (come in Palestina e in Ucraina) devono avere come obiettivo finale il rafforzamento della direzione rivoluzionaria tramite la mobilitazione e la propaganda, costruendo una connessione viva tra obiettivi immediati e la prospettiva anticapitalistica e riconducendo ogni lotta delle donne al processo più generale di emancipazione della classe lavoratrice, per una alternativa di società e di po